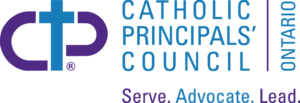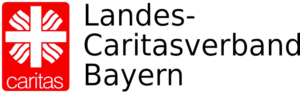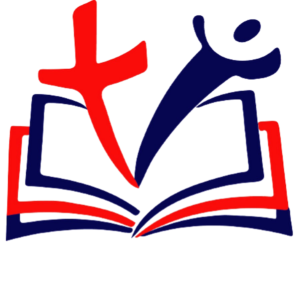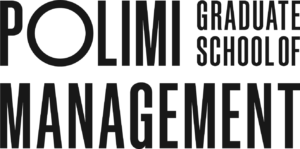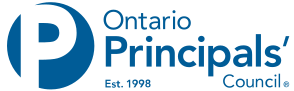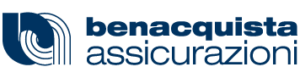Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Roberto Pellegatta
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
La dirigenza scolastica, un profilo problematico: specificità e caratteri del caso italiano di Giulio Salerno
La valutazione dei presidi statali in Italia: da dove si viene, dove si arriva di Dino Cristanini
La valutazione dei dirigenti scolastici in Francia e Inghilterra: uno studio comparativo di Gisella Langè
Strumenti e procedure per una valutazione della leadership in Canada-Ontario di Joanne Robinson
Valutazione e quadro sociale: la reputazione del dirigente scolastico. Guidare il cambiamento della scuola al tempo del “riformismo compulsivo” di Dario Nicoli
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
La valutazione della dirigenza sanitaria: un caso di servizio alle persone di Simona Giroldi
I limiti della procedura attuale e le proposte per un nuovo sistema di Ezio Delfino
La valutazione dei presidi statali in Italia: bilancio di una vicenda atipica di Antonino Petrolino
Profili di illegittimità del ‘portfolio’ per la valutazione del dirigente scolastico di Stefano Bianchini
Dalla formazione iniziale alla valutazione dei dirigenti: una ricerca scaturita da uno scambio transnazionale Italia – Canada di Angelo Paletta
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Le sorti dell’attuale valutazione della dirigenza: confronto aperto tra associazioni e sindacati scuola A cura di Roberto Pellegatta
PARTE IV - NORMATIVA
Un nuovo protagonismo delle Regioni per il rilancio dell’Istruzione e Formazione Professionale di Valentina Aprea
Quale scuola esce dai decreti attuativi? Riflessioni sulla nuova formazione iniziale e sul reclutamento docenti di Giuseppe Desideri
Valutare per migliorare: la valutazione nelle scuole e i nuovi esami col decreto 62 di Massimo Faggioli
La scuola da 0 a 6 anni: opportunità e compiti per chi dirige di Maria Pia Babini
Editoriale
1. Fin dai primi anni di lavoro nella compagnia professionale da cui poi sarebbe nata DiSAL, il tema della valutazione è stato tra le questioni privilegiate. Scrivevamo nel 1997 al Ministero che una corretta impostazione del problema esigeva chiarimenti sulla sua natura, sul suo significato: si era allora nel pieno della bufera culturale del “sistema qualità” che, provenendo dal mondo aziendale, iniziava ad invadere nel bene e nel male la scuola.
La pubblicistica e le bibliografie sul tema ci dicono che (tranne la traduzione di alcuni testi non italiani) il tutto ha inizio attorno alla fine degli anni ‘90 e contemporaneamente, sul piano normativo, nella legge 59/97 (e ancor meglio nel D.P.R. 275/99) si iniziava ad attribuire ai processi di valutazione un’importante funzione per la scuola dell’autonomia.
Ma cosa fosse e per chi fosse la “scuola dell’autonomia” in quegli anni non era certo una visione socialmente compresa. E tanto meno la vera natura del valutare.
Nella scuola da sempre sono solo i docenti che valutano gli alunni. Ma fino al 1991 anche i docenti ed i presidi venivano valutati, con una modalità di carattere burocratico. Grazie al sindacato vi fu poi esonero anche da questa parvenza.
Diversamente da quanto avviene nei sistemi scolastici europei, nel sistema americano e, dopo l’89, anche in tutti i paesi dell’ex sistema comunista, in Italia il tema “valutazione” applicato all’operato degli adulti nella scuola fa un’enorme fatica a prendere piede. Persino un ministro ci lasciò le penne! Non si trattava solo di difese corporative (comunque potenti), ma anche di una difficoltà culturale a comprendere effettivamente la natura del problema.
2. Da quando è nata, DiSAL va ripetendo che non esiste percorso di istruzione e formativo che possa prescindere da una valutazione, in tutti i suoi aspetti ed in tutti i suoi attori. C’è in gioco il valore stesso dell’attività svolta, del percorso seguito, dell’esito raggiunto. Valutare è appunto attribuire “valore” “ai fini di un giudizio o di una decisione”. Riflettere sul “valore” di un esito scolastico a confronto di un altro, sospingendo le comunità professionali a documentare questo valore, fa parte del cammino formativo, teso, nella sua natura, al proprio continuo miglioramento. Lo stesso OECD nel 2013 ne fece uno slogan felice: “utilizzare la valutazione per migliorare l’insegnamento”.
Infatti un esito o risultato ha valore anche in quanto ha pregnanza e forza significativa specie in relazione al fine che si persegue. Allora si tratta di assumere il tutto all’interno della relazione educativa, di ricomprendere la valutazione a partire dal proprio stretto legame con le relazioni interpersonali in gioco. Questa impostazione della natura del problema permette di chiarire che qualsiasi valutazione, in un servizio alla persona com’è quello della scuola (ma questa riflessione la si può reperire nel contributo di questo quaderno sulla sanità) non è riducibile ad una mera misurazione, in quanto gli elementi qualitativi delle relazioni personali non sono tutti di natura quantitativa. La ricognizione e la raccolta di elementi quantitativi misurabili, se costruita con questa consapevolezza ed in forma adeguata all’oggetto, può diventare così aiuto ed integrazione ad una pratica della valutazione più ampia e ricca e quindi più adeguata all’oggetto. Si tratta allora di liberarsi da schemi culturali di tipo tecnicistico o processuale, per costruire percorsi e strumenti realmente adeguati alla natura dell’oggetto, per contribuire a migliorare i processi formativi e di apprendimento.
3. Come redazione abbiamo quindi voluto ritrovare questa impostazione originaria anche all’interno della nuova incombenza, tanto contrastata, della valutazione del dirigente scolastico. Ne è uscito con sorpresa un quaderno che aiuta ad allargare lo sguardo e ci auguriamo contribuisca a riflettere su di una dimensione essenziale al sistema scolastico, utile quindi anche ad una moderna professione direttiva. Per questo impegno siamo grati a tutti gli esperti che hanno accettato di collaborare.
Anche quando nel 2002 (prima ancora dell’avvio del SiVaDiS) si iniziò la riflessione sulla valutazione della dirigenza scolastica (se ne vedano i materiali nella parte on-line di questo quaderno) , il problema principale non fu tanto l’individuazione degli indicatori che l’avrebbero permesso, ma la modalità di osservare, rilevare e valutare le azioni non misurabili, come tutto quanto attiene alla qualità delle relazioni interpersonali o all’incidenza dell’azione direttiva sugli apprendimenti degli alunni.
Da quegli anni la riflessione scientifica e le sperimentazioni hanno aiutato a focalizzare sempre meglio il problema, anche se, scorrendo le norme attuali in materia, leggendo le direttive o operando sugli strumenti ora costruiti per la valutazione della dirigenza scolastica (elementi ai quali è prevalentemente dedicato questo fascicolo) non sembra proprio che tutta questa riflessione abbia ispirato le scelte fatte.
La valutazione del dirigente scolastico (non certo cronologicamente, ma nella sua natura) è l’ultimo anello della propria catena professionale: “dovrebbe iniziare con il reclutamento; presuppone un profilo giuridico (comprensivo anche di una carriera) dotato di una chiara scelta di competenze chiave; comporta una formazione iniziale; necessita di una formazione in servizio adeguata alle competenze richieste. Fino ad arrivare alla struttura di un opportuno trattamento economico” (Cominelli).
Purtroppo, come si può desumere da questo quaderno (e anche da diversi contributi già del quaderno del giugno-agosto 2015 dedicato al profilo della dirigenza scolastica) gran parte di queste condizioni nel nostro ordinamento o non esistono o sono a spezzoni sparsi, poco coerenti tra loro, quando non contraddittori.
I contributi qui offerti documentano come la confusione di un profilo giuridico, sviluppatosi in modo disordinato e spesso contraddittorio (già a partire dalla clamorosa scelta di escludere docenti e personale non docente dal S.V.N. fatta nel D.L. 286/2004), determini la confusione e l’incertezza dello stesso percorso e del sistema valutativo. Sistema nato (come purtroppo tutte le riforme cruciali) all’interno di pesanti conflittualità sindacali tipiche solo del nostro caso nazionale.
Il tormentato avvio della valutazione della dirigenza scolastica in Italia, il cui destino è attualmente in forse, non può essere letto a prescindere da questo quadro e da questi condizionamenti, anche se il ripensamento dei percorsi e degli strumenti è condiviso da tutti, ovviamente per varie motivazioni.
Con questo quaderno vorremmo, forse con una certa presunzione, contribuire ad ampliare la riflessione, così che non sia condizionata dalla circostanza, ma sempre più adeguata allo scopo.
Da questo numero della rivista, poi, al tema prescelto si aggiunge una sezione di “attualità” che è dedicata all’esame dei principali aspetti dell’attuazione della legge di riforma 107/2015.
Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Roberto Pellegatta
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
La dirigenza scolastica, un profilo problematico: specificità e caratteri del caso italiano di Giulio Salerno
La valutazione dei presidi statali in Italia: da dove si viene, dove si arriva di Dino Cristanini
La valutazione dei dirigenti scolastici in Francia e Inghilterra: uno studio comparativo di Gisella Langè
Strumenti e procedure per una valutazione della leadership in Canada-Ontario di Joanne Robinson
Valutazione e quadro sociale: la reputazione del dirigente scolastico. Guidare il cambiamento della scuola al tempo del “riformismo compulsivo” di Dario Nicoli
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
La valutazione della dirigenza sanitaria: un caso di servizio alle persone di Simona Giroldi
I limiti della procedura attuale e le proposte per un nuovo sistema di Ezio Delfino
La valutazione dei presidi statali in Italia: bilancio di una vicenda atipica di Antonino Petrolino
Profili di illegittimità del ‘portfolio’ per la valutazione del dirigente scolastico di Stefano Bianchini
Dalla formazione iniziale alla valutazione dei dirigenti: una ricerca scaturita da uno scambio transnazionale Italia – Canada di Angelo Paletta
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Le sorti dell’attuale valutazione della dirigenza: confronto aperto tra associazioni e sindacati scuola A cura di Roberto Pellegatta
PARTE IV - NORMATIVA
Un nuovo protagonismo delle Regioni per il rilancio dell’Istruzione e Formazione Professionale di Valentina Aprea
Quale scuola esce dai decreti attuativi? Riflessioni sulla nuova formazione iniziale e sul reclutamento docenti di Giuseppe Desideri
Valutare per migliorare: la valutazione nelle scuole e i nuovi esami col decreto 62 di Massimo Faggioli
La scuola da 0 a 6 anni: opportunità e compiti per chi dirige di Maria Pia Babini
Editoriale
1. Fin dai primi anni di lavoro nella compagnia professionale da cui poi sarebbe nata DiSAL, il tema della valutazione è stato tra le questioni privilegiate. Scrivevamo nel 1997 al Ministero che una corretta impostazione del problema esigeva chiarimenti sulla sua natura, sul suo significato: si era allora nel pieno della bufera culturale del “sistema qualità” che, provenendo dal mondo aziendale, iniziava ad invadere nel bene e nel male la scuola.
La pubblicistica e le bibliografie sul tema ci dicono che (tranne la traduzione di alcuni testi non italiani) il tutto ha inizio attorno alla fine degli anni ‘90 e contemporaneamente, sul piano normativo, nella legge 59/97 (e ancor meglio nel D.P.R. 275/99) si iniziava ad attribuire ai processi di valutazione un’importante funzione per la scuola dell’autonomia.
Ma cosa fosse e per chi fosse la “scuola dell’autonomia” in quegli anni non era certo una visione socialmente compresa. E tanto meno la vera natura del valutare.
Nella scuola da sempre sono solo i docenti che valutano gli alunni. Ma fino al 1991 anche i docenti ed i presidi venivano valutati, con una modalità di carattere burocratico. Grazie al sindacato vi fu poi esonero anche da questa parvenza.
Diversamente da quanto avviene nei sistemi scolastici europei, nel sistema americano e, dopo l’89, anche in tutti i paesi dell’ex sistema comunista, in Italia il tema “valutazione” applicato all’operato degli adulti nella scuola fa un’enorme fatica a prendere piede. Persino un ministro ci lasciò le penne! Non si trattava solo di difese corporative (comunque potenti), ma anche di una difficoltà culturale a comprendere effettivamente la natura del problema.
2. Da quando è nata, DiSAL va ripetendo che non esiste percorso di istruzione e formativo che possa prescindere da una valutazione, in tutti i suoi aspetti ed in tutti i suoi attori. C’è in gioco il valore stesso dell’attività svolta, del percorso seguito, dell’esito raggiunto. Valutare è appunto attribuire “valore” “ai fini di un giudizio o di una decisione”. Riflettere sul “valore” di un esito scolastico a confronto di un altro, sospingendo le comunità professionali a documentare questo valore, fa parte del cammino formativo, teso, nella sua natura, al proprio continuo miglioramento. Lo stesso OECD nel 2013 ne fece uno slogan felice: “utilizzare la valutazione per migliorare l’insegnamento”.
Infatti un esito o risultato ha valore anche in quanto ha pregnanza e forza significativa specie in relazione al fine che si persegue. Allora si tratta di assumere il tutto all’interno della relazione educativa, di ricomprendere la valutazione a partire dal proprio stretto legame con le relazioni interpersonali in gioco. Questa impostazione della natura del problema permette di chiarire che qualsiasi valutazione, in un servizio alla persona com’è quello della scuola (ma questa riflessione la si può reperire nel contributo di questo quaderno sulla sanità) non è riducibile ad una mera misurazione, in quanto gli elementi qualitativi delle relazioni personali non sono tutti di natura quantitativa. La ricognizione e la raccolta di elementi quantitativi misurabili, se costruita con questa consapevolezza ed in forma adeguata all’oggetto, può diventare così aiuto ed integrazione ad una pratica della valutazione più ampia e ricca e quindi più adeguata all’oggetto. Si tratta allora di liberarsi da schemi culturali di tipo tecnicistico o processuale, per costruire percorsi e strumenti realmente adeguati alla natura dell’oggetto, per contribuire a migliorare i processi formativi e di apprendimento.
3. Come redazione abbiamo quindi voluto ritrovare questa impostazione originaria anche all’interno della nuova incombenza, tanto contrastata, della valutazione del dirigente scolastico. Ne è uscito con sorpresa un quaderno che aiuta ad allargare lo sguardo e ci auguriamo contribuisca a riflettere su di una dimensione essenziale al sistema scolastico, utile quindi anche ad una moderna professione direttiva. Per questo impegno siamo grati a tutti gli esperti che hanno accettato di collaborare.
Anche quando nel 2002 (prima ancora dell’avvio del SiVaDiS) si iniziò la riflessione sulla valutazione della dirigenza scolastica (se ne vedano i materiali nella parte on-line di questo quaderno) , il problema principale non fu tanto l’individuazione degli indicatori che l’avrebbero permesso, ma la modalità di osservare, rilevare e valutare le azioni non misurabili, come tutto quanto attiene alla qualità delle relazioni interpersonali o all’incidenza dell’azione direttiva sugli apprendimenti degli alunni.
Da quegli anni la riflessione scientifica e le sperimentazioni hanno aiutato a focalizzare sempre meglio il problema, anche se, scorrendo le norme attuali in materia, leggendo le direttive o operando sugli strumenti ora costruiti per la valutazione della dirigenza scolastica (elementi ai quali è prevalentemente dedicato questo fascicolo) non sembra proprio che tutta questa riflessione abbia ispirato le scelte fatte.
La valutazione del dirigente scolastico (non certo cronologicamente, ma nella sua natura) è l’ultimo anello della propria catena professionale: “dovrebbe iniziare con il reclutamento; presuppone un profilo giuridico (comprensivo anche di una carriera) dotato di una chiara scelta di competenze chiave; comporta una formazione iniziale; necessita di una formazione in servizio adeguata alle competenze richieste. Fino ad arrivare alla struttura di un opportuno trattamento economico” (Cominelli).
Purtroppo, come si può desumere da questo quaderno (e anche da diversi contributi già del quaderno del giugno-agosto 2015 dedicato al profilo della dirigenza scolastica) gran parte di queste condizioni nel nostro ordinamento o non esistono o sono a spezzoni sparsi, poco coerenti tra loro, quando non contraddittori.
I contributi qui offerti documentano come la confusione di un profilo giuridico, sviluppatosi in modo disordinato e spesso contraddittorio (già a partire dalla clamorosa scelta di escludere docenti e personale non docente dal S.V.N. fatta nel D.L. 286/2004), determini la confusione e l’incertezza dello stesso percorso e del sistema valutativo. Sistema nato (come purtroppo tutte le riforme cruciali) all’interno di pesanti conflittualità sindacali tipiche solo del nostro caso nazionale.
Il tormentato avvio della valutazione della dirigenza scolastica in Italia, il cui destino è attualmente in forse, non può essere letto a prescindere da questo quadro e da questi condizionamenti, anche se il ripensamento dei percorsi e degli strumenti è condiviso da tutti, ovviamente per varie motivazioni.
Con questo quaderno vorremmo, forse con una certa presunzione, contribuire ad ampliare la riflessione, così che non sia condizionata dalla circostanza, ma sempre più adeguata allo scopo.
Da questo numero della rivista, poi, al tema prescelto si aggiunge una sezione di “attualità” che è dedicata all’esame dei principali aspetti dell’attuazione della legge di riforma 107/2015.