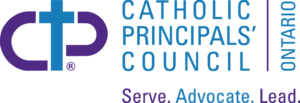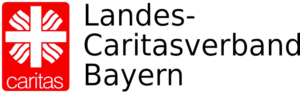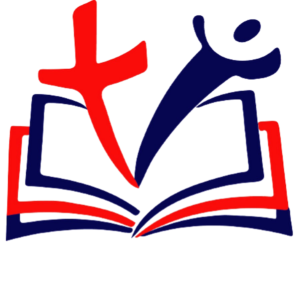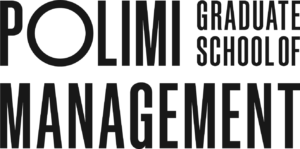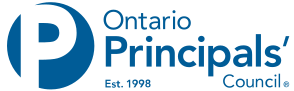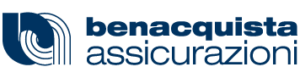Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Roberto Pellegatta
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
Etica dell’educazione, solidarietà e modelli educativi di Rocco Buttiglione
Oltre il metodo: il canone formativo di Dario Eugenio Nicoli
Leggere oggi la scuola di domani: urgenze, temi, prospettive di Marcello Tempesta
Corresponsabilità educativa: scuola e famiglia, un bilancio difficile di Giovanni Cominelli
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Se faccio, capisco. La proposta pedagogica del service learning di Italo Fiorin - Irene Culcasi
L’esercizio della autonomia nel dirigere scuole: creare legami a servizio di un territorio di Angelo Paletta
Community leadership: una direzione educativa per la comunità di Giuseppe Meroni
Famiglia, giovani, territorio. Per accendere un dialogo formativo di Sergio Astori
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
A scuola di service learning. Dal “fare” al “dire” parlano le buone pratiche di Simone Consegnati
Catania: una scuola a servizio del proprio quartiere di Maria Paola Iaquinta
Sassello: scuole di montagna come servizio alle comunità di Lia Zunino
Organizzare la scuola come comunità di apprendimento di Roberto Pellegatta
Educazione e multiculturalità: la sfida educativa delle scuole cattoliche di Sarajevo di Mons. Pero Suda
Un nuovo contesto formativo dal rapporto col territorio di Davide Brasca
PARTE IV - NORMATIVA
Superiori a quattro anni: un’opportunità di Angela Nadia Cattaneo - Elide Casati
La scuola media: una terra di mezzo con una propria identità di Giancarlo Cerini
Scuola secondaria di primo grado: da anello debole a opportunità di Giuseppe Santoli
Editoriale
Da qualche tempo, nelle realtà vive della scuola italiana, ci si interroga sulla via migliore e sugli adeguati fondamenti per superare quella frattura tra scuola e vita che caratterizza gran parte del nostro sistema formativo (scolastico e universitario).
Frattura i cui esiti sono leggibili da tempo da una pluralità di segnali, sistemici (come la dispersione, le debolezze negli indici internazionali o la disoccupazione giovanile) o esistenziali (come la noia, la fragilità di motivazioni allo studio, le difficoltà professionali dei docenti). Qualche isolato intervento di sistema – come ad es. l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro – sembra tentare di rimettere in movimento e di superare questa frattura: ma purtroppo si tratta di pezze buone attaccate ad un abito di tessuto pessimo. Non a caso abbiamo assistito, proprio da parte di molto mondo giovanile, al rifiuto dell’alternanza, rifiuto purtroppo vitalizzato anche dal virus delle distorsioni ideologiche di cui la scuola persiste ad essere l’ultimo bacino di coltivazione, perpetrando così per diverse situazioni la propria natura conservativa e avversa alla modernità.
Di molte cose ha bisogno urgente la scuola italiana, ma soprattutto di “riconciliare la scuola con la vita” (Dario Nicoli) e questo sta già accadendo in alcune esperienze significative laddove torna ad essere protagonista tutta la comunità scolastica, in particolare gli studenti e i docenti.
È questo, sia detto per inciso, mostra il possibile contributo, oggi, di un preside alla scuola del domani: diventare un professionista che sa cogliere il nuovo che nasce ogni giorno, che cerca di valorizzarlo, di favorirne la riflessione, di garantirgli strumenti operativi, di renderlo condivisibile.
Riconciliare la scuola con la vita non può avvenire se non con profondi mutamenti dell’insegnamento, dei curricoli, delle metodologie, assieme alle forme di vita di una scuola, ai suoi ritmi, agli orari, agli spazi ed a tutte quelle attività che debbono creare continua osmosi tra “dentro” e “fuori” le mura, specie laddove un alunno fa esperienza diretta e ragionevole del reale, primo e fondamentale alimento di ogni percorso educativo.
Questo movimento verso un “nuovo canone formativo” esige fondamenti, riflessioni ed esperienze che sappiano sfuggire al didatticismo (non al rinnovamento della didattica), al predominio delle metodologie (non al rinnovamento dei metodi), all’attivismo extracurricolare (non all’integrazione tra curricolo e vita sociale), all’assolutizzazione della cultura (non ad una cultura a servizio della vita), all’isolamento scolastico (non alla cura della propria comunità).
A questi tentativi è dedicato questo quaderno, nella speranza di proporre vie e cammini d’uscita dalla crisi, utili alla riflessione. Nella tradizione della nostra rivista – maturata alla luce dei propri “maestri” che più volte abbiamo indicato (don Luigi Giussani, Cesare Scurati) – abbiamo fin dagli inizi scelto di non limitarci ad analisi, pur interessanti andando alla ricerca di voci che nel mondo universitario e in quello scolastico sappiano offrire suggestioni utili a superare la frattura segnalata.
In questo numero abbiamo scelto, magari confusamente vista la complessità del problema, di coinvolgere voci ed esperienze che sappiano lasciarsi interrogare dalla crisi della scuola e dell’educazione, che non ripetano stancamente discorsi copiati dai libri, ripetuti da circolari o da stanchi corsi di formazione, che non si trastullino inconsapevoli con nuove mode o tecniche d’aula.
Molte suggestioni metodologiche sono interessanti, a cominciare dalla didattica per competenze o dall’attenzione ad altre metodologie. Ma tutte queste, come alcune riflessioni del quaderno ci aiutano a capire, alla lunga rigenerano unità con la vita e quindi motivazione ed energia nella fatica dello studio, solo se ritrovano una radice culturalmente significativa, un legame con le attese più vere dei giovani.
Una particolare attenzione si è scelto di dare all’esperienza del Service Learning (o apprendimento e servizio), che tenta la strada di un umanesimo personalistico e comunitario, sperimentando cammini di continua relazione tra il dentro dell’aula e il fuori del mondo, tra il dentro della teoria e il fuori della pratica, specie se fatta di esperienze solidali, dove lo studente scopre di essere fatto di “legami”.
Il Service Learning, molto diffuso a livello internazionale, specie negli Stati Uniti e nell’America Latina, spinge a considerare l’apprendere in modo sempre più integrato ed esperienziale, indirizzandolo verso la maturazione di una responsabilità sociale, verso un servizio reale alle comunità di appartenenza degli studenti.
Infine, tra le questioni attuali che ci … sommergono, si è scelto di riflettere su due problematiche inerenti l’urgenza di una riformulazione del percorso scolastico nazionale: la durata della scuola superiore di secondo grado e la problematicità sempre più seria della scuola superiore di primo grado, la nostra scuola media non da ora individuata come “l’anello debole” del sistema.
Alcuni documenti di approfondimento sono rimandati, con accesso libero, all’edizione online della rivista così che i testi del quaderno (per i quali confermo la nostra gratitudine agli autori) operino come spunto ad una ricerca, di cui nelle nostre scuole abbiamo molto bisogno, anche se la ricerca di spazi di riflessione deve sempre di più combattere contro le molestie burocratiche che invadono il quotidiano formativo.
Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Roberto Pellegatta
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
Etica dell’educazione, solidarietà e modelli educativi di Rocco Buttiglione
Oltre il metodo: il canone formativo di Dario Eugenio Nicoli
Leggere oggi la scuola di domani: urgenze, temi, prospettive di Marcello Tempesta
Corresponsabilità educativa: scuola e famiglia, un bilancio difficile di Giovanni Cominelli
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Se faccio, capisco. La proposta pedagogica del service learning di Italo Fiorin - Irene Culcasi
L’esercizio della autonomia nel dirigere scuole: creare legami a servizio di un territorio di Angelo Paletta
Community leadership: una direzione educativa per la comunità di Giuseppe Meroni
Famiglia, giovani, territorio. Per accendere un dialogo formativo di Sergio Astori
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
A scuola di service learning. Dal “fare” al “dire” parlano le buone pratiche di Simone Consegnati
Catania: una scuola a servizio del proprio quartiere di Maria Paola Iaquinta
Sassello: scuole di montagna come servizio alle comunità di Lia Zunino
Organizzare la scuola come comunità di apprendimento di Roberto Pellegatta
Educazione e multiculturalità: la sfida educativa delle scuole cattoliche di Sarajevo di Mons. Pero Suda
Un nuovo contesto formativo dal rapporto col territorio di Davide Brasca
PARTE IV - NORMATIVA
Superiori a quattro anni: un’opportunità di Angela Nadia Cattaneo - Elide Casati
La scuola media: una terra di mezzo con una propria identità di Giancarlo Cerini
Scuola secondaria di primo grado: da anello debole a opportunità di Giuseppe Santoli
Editoriale
Da qualche tempo, nelle realtà vive della scuola italiana, ci si interroga sulla via migliore e sugli adeguati fondamenti per superare quella frattura tra scuola e vita che caratterizza gran parte del nostro sistema formativo (scolastico e universitario).
Frattura i cui esiti sono leggibili da tempo da una pluralità di segnali, sistemici (come la dispersione, le debolezze negli indici internazionali o la disoccupazione giovanile) o esistenziali (come la noia, la fragilità di motivazioni allo studio, le difficoltà professionali dei docenti). Qualche isolato intervento di sistema – come ad es. l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro – sembra tentare di rimettere in movimento e di superare questa frattura: ma purtroppo si tratta di pezze buone attaccate ad un abito di tessuto pessimo. Non a caso abbiamo assistito, proprio da parte di molto mondo giovanile, al rifiuto dell’alternanza, rifiuto purtroppo vitalizzato anche dal virus delle distorsioni ideologiche di cui la scuola persiste ad essere l’ultimo bacino di coltivazione, perpetrando così per diverse situazioni la propria natura conservativa e avversa alla modernità.
Di molte cose ha bisogno urgente la scuola italiana, ma soprattutto di “riconciliare la scuola con la vita” (Dario Nicoli) e questo sta già accadendo in alcune esperienze significative laddove torna ad essere protagonista tutta la comunità scolastica, in particolare gli studenti e i docenti.
È questo, sia detto per inciso, mostra il possibile contributo, oggi, di un preside alla scuola del domani: diventare un professionista che sa cogliere il nuovo che nasce ogni giorno, che cerca di valorizzarlo, di favorirne la riflessione, di garantirgli strumenti operativi, di renderlo condivisibile.
Riconciliare la scuola con la vita non può avvenire se non con profondi mutamenti dell’insegnamento, dei curricoli, delle metodologie, assieme alle forme di vita di una scuola, ai suoi ritmi, agli orari, agli spazi ed a tutte quelle attività che debbono creare continua osmosi tra “dentro” e “fuori” le mura, specie laddove un alunno fa esperienza diretta e ragionevole del reale, primo e fondamentale alimento di ogni percorso educativo.
Questo movimento verso un “nuovo canone formativo” esige fondamenti, riflessioni ed esperienze che sappiano sfuggire al didatticismo (non al rinnovamento della didattica), al predominio delle metodologie (non al rinnovamento dei metodi), all’attivismo extracurricolare (non all’integrazione tra curricolo e vita sociale), all’assolutizzazione della cultura (non ad una cultura a servizio della vita), all’isolamento scolastico (non alla cura della propria comunità).
A questi tentativi è dedicato questo quaderno, nella speranza di proporre vie e cammini d’uscita dalla crisi, utili alla riflessione. Nella tradizione della nostra rivista – maturata alla luce dei propri “maestri” che più volte abbiamo indicato (don Luigi Giussani, Cesare Scurati) – abbiamo fin dagli inizi scelto di non limitarci ad analisi, pur interessanti andando alla ricerca di voci che nel mondo universitario e in quello scolastico sappiano offrire suggestioni utili a superare la frattura segnalata.
In questo numero abbiamo scelto, magari confusamente vista la complessità del problema, di coinvolgere voci ed esperienze che sappiano lasciarsi interrogare dalla crisi della scuola e dell’educazione, che non ripetano stancamente discorsi copiati dai libri, ripetuti da circolari o da stanchi corsi di formazione, che non si trastullino inconsapevoli con nuove mode o tecniche d’aula.
Molte suggestioni metodologiche sono interessanti, a cominciare dalla didattica per competenze o dall’attenzione ad altre metodologie. Ma tutte queste, come alcune riflessioni del quaderno ci aiutano a capire, alla lunga rigenerano unità con la vita e quindi motivazione ed energia nella fatica dello studio, solo se ritrovano una radice culturalmente significativa, un legame con le attese più vere dei giovani.
Una particolare attenzione si è scelto di dare all’esperienza del Service Learning (o apprendimento e servizio), che tenta la strada di un umanesimo personalistico e comunitario, sperimentando cammini di continua relazione tra il dentro dell’aula e il fuori del mondo, tra il dentro della teoria e il fuori della pratica, specie se fatta di esperienze solidali, dove lo studente scopre di essere fatto di “legami”.
Il Service Learning, molto diffuso a livello internazionale, specie negli Stati Uniti e nell’America Latina, spinge a considerare l’apprendere in modo sempre più integrato ed esperienziale, indirizzandolo verso la maturazione di una responsabilità sociale, verso un servizio reale alle comunità di appartenenza degli studenti.
Infine, tra le questioni attuali che ci … sommergono, si è scelto di riflettere su due problematiche inerenti l’urgenza di una riformulazione del percorso scolastico nazionale: la durata della scuola superiore di secondo grado e la problematicità sempre più seria della scuola superiore di primo grado, la nostra scuola media non da ora individuata come “l’anello debole” del sistema.
Alcuni documenti di approfondimento sono rimandati, con accesso libero, all’edizione online della rivista così che i testi del quaderno (per i quali confermo la nostra gratitudine agli autori) operino come spunto ad una ricerca, di cui nelle nostre scuole abbiamo molto bisogno, anche se la ricerca di spazi di riflessione deve sempre di più combattere contro le molestie burocratiche che invadono il quotidiano formativo.