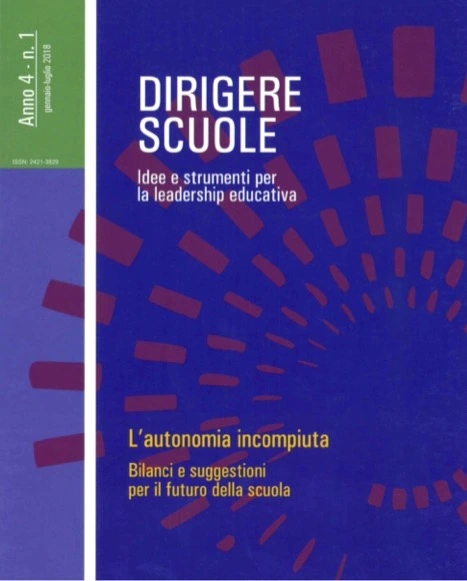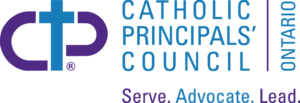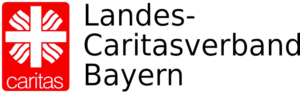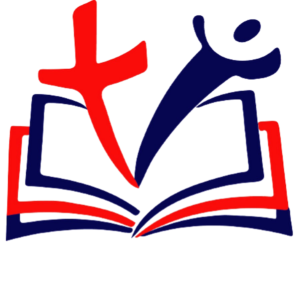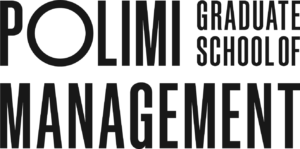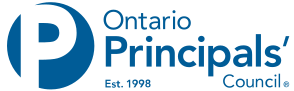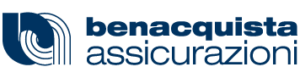Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Roberto Pellegatta
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
Autonomia scolastica: la storia, le ragioni e una sfida da riprendere di Luigi Berlinguer
Il lungo processo dell’autonomia scolastica tra crisi e sviluppo di Giuseppe Cosentino
L’autonomia tra opportunità e fallimento di Giovanni Cominelli
Un movimento di scuole per l’autonomia a c. di Dario Nicoli
La scuola nella revisione costituzionale del titolo V: autonomia e nuova organizzazione dello stato di Anna Maria Poggi
L’autonomia scolastica migliora l’apprendimento? Quale miglioramento per quale scuola? di Giorgio Chiosso
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Scuole autonome in Europa: i casi di Finlandia, Inghilterra, Olanda di Giovanni Biondi, Simona Baggiani, Erica Cimò, e Alessandra Mochi
L’autonomia possibile: Charter school e Academy britanniche, lezioni dal mondo di Luisa Ribolzi
Gli organi di governo della scuola: una storia e le sue prospettive di Antonino Petrolino
Il costo standard: uno strumento per l’autonomia e la libertà delle scuole di suor Monia Alfieri
Autonomia finanziaria della scuola: vincoli della contabilità di stato e possibilità di superarli di Francesco Bragagni
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Reti e alleanze territoriali strumenti di autonomia: pensare “out of the box” di Roberta Fantinato e Roberto Fiorini
Autonomia didattica: modalità alternative di pensare al tempo scuola, al quadro orario, alla classe e ai laboratori di Ilaria Bernecich, Emanuela Pisoni e Maria Alessandra Capelloni
La scuola paritaria come modello di autonomia nella didattica, nell’organizzazione e nel rapporto col territorio di Elena Ugolini
L’autonomia scolastica italiana “a rischio”. Un confronto internazionale di Maria Paola Iaquinta
La scuola nelle richieste di autonomia regionale in Lombardia di Valentina Aprea
PARTE IV - NORMATIVA
Mutamenti all’esame di Stato del I ciclo tra nuovo e antico di Nora Terzoli
L’esame di Stato conclusivo del II ciclo tra luci e ombre di Mauro Monti
Editoriale
1. Che ne è stato dell’autonomia scolastica? Introdotta nel dibattito italiano già da Giovanni Gozzer in una sua lucida riflessione del 1964 come idea chiave per risolvere il rapporto tra stato e scuola, ripresa poi da alcuni ministri dell’istru- zione nei loro tentativi di riorganizzare il sistema scolastico italiano, giunge al primo (… e ultimo) inquadramento normativo con la legge 59/1997 e con il D.P.R. 275/1999, Regolamento attuativo che purtroppo non ha trovato effettiva attuazione e che tutt’ora resta l’unico e valido riferimento sistemico. L’ultimo tentativo di tornare su di un sistema di scuole autonome risale al Progetto di Legge “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali” frutto della VII Com- missione della Camera del 10 ottobre 2012: ma si trattava solamente di una riforma degli organi collegiali.
Che ne è stato dunque dell’autonomia scolastica? Gli aggettivi si sono spre- cati: incompiuta, inattuata, congelata, quando non tradita. Eppure sistematicamente ogni volta si torna ad indicarla come unica via per mettere valide basi per un rinnovato sistema scolastico. Nelle stesse vicende internazionali l’istanza autonomistica nei sistemi scolastici ha subito vicende alterne: vada per tutti il caso inglese, patria delle autonomie istituzionali, dove negli anni ’90 si tentò addirittura una retromarcia verso il governo centrale.
2. Ancora oggi il problema del governo della scuola e delle relazioni tra scuola e stato resta un’emergenza istituzionale del sistema italiano. Proponendo qui ricostruzioni e suggestioni sul tema, non ci interessano aspetti particolari di ingegneria istituzionale, ma la ripresa di un dialogo sulle ragioni ed i caratteri di un rinnovamento del sistema scuola, che recuperi l’efficacia perduta, l’adeguatezza ai tempi, ai bisogni culturali, educativi ed economici di oggi.
Consapevoli della complessità e (occorre riconoscerlo) della difficoltà a riproporre oggi la grande prospettiva autonomista, il quadro dei contributi proposti (per i quali siamo sempre grati ai nostri autori e collaboratori) spazia da riflessioni sulla crisi storica dell’idea, a confronti e paragoni con contesti internazionali dai quali si possa imparare; da approfondimenti inerenti particolari condizioni per un possibile sistema di scuole autonome, ad esperienze che hanno utilizzato gli spazi concessi dalle norme attuali per una progettazione innovativa, attenta ai reali bisogni dei giovani. Primo fra tutti i contributi quello di Luigi Berlinguer, vero protagonista dell’autonomia scolastica in Italia: del “padre dell’autonomia” ospitiamo un contributo eccezionale per l’aspetto anche biografico.
La sezione di questo quaderno dedicata poi all’attualità si occupa delle novità introdotte per gli esami di stato finali del I e II ciclo, che suscitano non poche problematiche proprio ad una progettazione didattica autonoma delle scuole.
3. Il problema della governance delle scuole statali in Italia ha raggiunto livelli di crisi allarmanti. Basti pensare solo al fatto che a settembre di quest’anno mancherà alle scuole quasi un terzo dei dirigenti scolastici titolari. Un buco di efficacia mai avvenuto in 160 anni di scuola statale.
Tuttavia, e più a fondo, il grave stato di empasse istituzionale nasce dalla mancata risposta ad una domanda cruciale per il rilancio dell’autonomia scolastica, domanda che DiSAL, già nel proprio convegno del 2004, aveva così espressa: a chi appartiene la scuola? Non si può delineare un quadro istituzionale chiaro se non si decide previamente se la scuola italiana debba restare in capo ad uno stato centrale efficiente ed organizzato (ammesso che sia oggi possibile), o debba trasferirsi alle regioni, oppure se debba appartenere alle comunità locali ed ai soggetti sociali che le costituiscono. Occorre scegliere, consapevoli che la scelta per una visione complessiva porta itrinsecamente con sé anche la scelta sulla problematica della scuola non statale (e più in generale della libertà educativa). DiSAL ha sostenuto dai propri inizi le ragioni per le quali non si possa disgiungere appunto l’autonomia dalla parità.
Le ricerche e le vicende internazionali ci dicono che qualcosa cambierà di sicuro nei prossimi decenni: i movimenti complessivi vanno verso scuole sempre più autonome, con il dovere di rendere conto di quel che fanno, con programmi scolastici sempre meno uniformi fra le scuole di un paese, con una valutazione delle scuole, degli insegnanti, dei dirigenti che diventerà la regola con tutte le conseguenze del caso.
Il vero e grande valore dell’autonomia sta nel consentire alle scuole, slegandosi dalla gestione centrale, di esercitare la responsabilità di rispondere ai bisogni delle proprie comunità e dei proprio giovani. Riprendere sul serio un dibattito sull’autonomia scolastica è compito serio e urgente per il quale occorre prendere decisioni chiare e impegni forti.
Perché questo accada servono: un gruppo dirigente portatore di una chiara visione e capace di assumersi la responsabilità necessarie; professionisti dell’istruzione e dell’educazione preparati ed appassionati; margini normativi adeguati all’azione; un ceto politico convinto sostenitore del rinnovamento.
Speriamo con questo quaderno di offrire strumenti e riflessioni che portino il coraggio di una nuova visione e aiutino la ripresa di questo cammino.
Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Roberto Pellegatta
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
Autonomia scolastica: la storia, le ragioni e una sfida da riprendere di Luigi Berlinguer
Il lungo processo dell’autonomia scolastica tra crisi e sviluppo di Giuseppe Cosentino
L’autonomia tra opportunità e fallimento di Giovanni Cominelli
Un movimento di scuole per l’autonomia a c. di Dario Nicoli
La scuola nella revisione costituzionale del titolo V: autonomia e nuova organizzazione dello stato di Anna Maria Poggi
L’autonomia scolastica migliora l’apprendimento? Quale miglioramento per quale scuola? di Giorgio Chiosso
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Scuole autonome in Europa: i casi di Finlandia, Inghilterra, Olanda di Giovanni Biondi, Simona Baggiani, Erica Cimò, e Alessandra Mochi
L’autonomia possibile: Charter school e Academy britanniche, lezioni dal mondo di Luisa Ribolzi
Gli organi di governo della scuola: una storia e le sue prospettive di Antonino Petrolino
Il costo standard: uno strumento per l’autonomia e la libertà delle scuole di suor Monia Alfieri
Autonomia finanziaria della scuola: vincoli della contabilità di stato e possibilità di superarli di Francesco Bragagni
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Reti e alleanze territoriali strumenti di autonomia: pensare “out of the box” di Roberta Fantinato e Roberto Fiorini
Autonomia didattica: modalità alternative di pensare al tempo scuola, al quadro orario, alla classe e ai laboratori di Ilaria Bernecich, Emanuela Pisoni e Maria Alessandra Capelloni
La scuola paritaria come modello di autonomia nella didattica, nell’organizzazione e nel rapporto col territorio di Elena Ugolini
L’autonomia scolastica italiana “a rischio”. Un confronto internazionale di Maria Paola Iaquinta
La scuola nelle richieste di autonomia regionale in Lombardia di Valentina Aprea
PARTE IV - NORMATIVA
Mutamenti all’esame di Stato del I ciclo tra nuovo e antico di Nora Terzoli
L’esame di Stato conclusivo del II ciclo tra luci e ombre di Mauro Monti
Editoriale
1. Che ne è stato dell’autonomia scolastica? Introdotta nel dibattito italiano già da Giovanni Gozzer in una sua lucida riflessione del 1964 come idea chiave per risolvere il rapporto tra stato e scuola, ripresa poi da alcuni ministri dell’istru- zione nei loro tentativi di riorganizzare il sistema scolastico italiano, giunge al primo (… e ultimo) inquadramento normativo con la legge 59/1997 e con il D.P.R. 275/1999, Regolamento attuativo che purtroppo non ha trovato effettiva attuazione e che tutt’ora resta l’unico e valido riferimento sistemico. L’ultimo tentativo di tornare su di un sistema di scuole autonome risale al Progetto di Legge “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali” frutto della VII Com- missione della Camera del 10 ottobre 2012: ma si trattava solamente di una riforma degli organi collegiali.
Che ne è stato dunque dell’autonomia scolastica? Gli aggettivi si sono spre- cati: incompiuta, inattuata, congelata, quando non tradita. Eppure sistematicamente ogni volta si torna ad indicarla come unica via per mettere valide basi per un rinnovato sistema scolastico. Nelle stesse vicende internazionali l’istanza autonomistica nei sistemi scolastici ha subito vicende alterne: vada per tutti il caso inglese, patria delle autonomie istituzionali, dove negli anni ’90 si tentò addirittura una retromarcia verso il governo centrale.
2. Ancora oggi il problema del governo della scuola e delle relazioni tra scuola e stato resta un’emergenza istituzionale del sistema italiano. Proponendo qui ricostruzioni e suggestioni sul tema, non ci interessano aspetti particolari di ingegneria istituzionale, ma la ripresa di un dialogo sulle ragioni ed i caratteri di un rinnovamento del sistema scuola, che recuperi l’efficacia perduta, l’adeguatezza ai tempi, ai bisogni culturali, educativi ed economici di oggi.
Consapevoli della complessità e (occorre riconoscerlo) della difficoltà a riproporre oggi la grande prospettiva autonomista, il quadro dei contributi proposti (per i quali siamo sempre grati ai nostri autori e collaboratori) spazia da riflessioni sulla crisi storica dell’idea, a confronti e paragoni con contesti internazionali dai quali si possa imparare; da approfondimenti inerenti particolari condizioni per un possibile sistema di scuole autonome, ad esperienze che hanno utilizzato gli spazi concessi dalle norme attuali per una progettazione innovativa, attenta ai reali bisogni dei giovani. Primo fra tutti i contributi quello di Luigi Berlinguer, vero protagonista dell’autonomia scolastica in Italia: del “padre dell’autonomia” ospitiamo un contributo eccezionale per l’aspetto anche biografico.
La sezione di questo quaderno dedicata poi all’attualità si occupa delle novità introdotte per gli esami di stato finali del I e II ciclo, che suscitano non poche problematiche proprio ad una progettazione didattica autonoma delle scuole.
3. Il problema della governance delle scuole statali in Italia ha raggiunto livelli di crisi allarmanti. Basti pensare solo al fatto che a settembre di quest’anno mancherà alle scuole quasi un terzo dei dirigenti scolastici titolari. Un buco di efficacia mai avvenuto in 160 anni di scuola statale.
Tuttavia, e più a fondo, il grave stato di empasse istituzionale nasce dalla mancata risposta ad una domanda cruciale per il rilancio dell’autonomia scolastica, domanda che DiSAL, già nel proprio convegno del 2004, aveva così espressa: a chi appartiene la scuola? Non si può delineare un quadro istituzionale chiaro se non si decide previamente se la scuola italiana debba restare in capo ad uno stato centrale efficiente ed organizzato (ammesso che sia oggi possibile), o debba trasferirsi alle regioni, oppure se debba appartenere alle comunità locali ed ai soggetti sociali che le costituiscono. Occorre scegliere, consapevoli che la scelta per una visione complessiva porta itrinsecamente con sé anche la scelta sulla problematica della scuola non statale (e più in generale della libertà educativa). DiSAL ha sostenuto dai propri inizi le ragioni per le quali non si possa disgiungere appunto l’autonomia dalla parità.
Le ricerche e le vicende internazionali ci dicono che qualcosa cambierà di sicuro nei prossimi decenni: i movimenti complessivi vanno verso scuole sempre più autonome, con il dovere di rendere conto di quel che fanno, con programmi scolastici sempre meno uniformi fra le scuole di un paese, con una valutazione delle scuole, degli insegnanti, dei dirigenti che diventerà la regola con tutte le conseguenze del caso.
Il vero e grande valore dell’autonomia sta nel consentire alle scuole, slegandosi dalla gestione centrale, di esercitare la responsabilità di rispondere ai bisogni delle proprie comunità e dei proprio giovani. Riprendere sul serio un dibattito sull’autonomia scolastica è compito serio e urgente per il quale occorre prendere decisioni chiare e impegni forti.
Perché questo accada servono: un gruppo dirigente portatore di una chiara visione e capace di assumersi la responsabilità necessarie; professionisti dell’istruzione e dell’educazione preparati ed appassionati; margini normativi adeguati all’azione; un ceto politico convinto sostenitore del rinnovamento.
Speriamo con questo quaderno di offrire strumenti e riflessioni che portino il coraggio di una nuova visione e aiutino la ripresa di questo cammino.