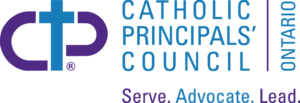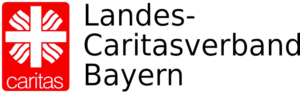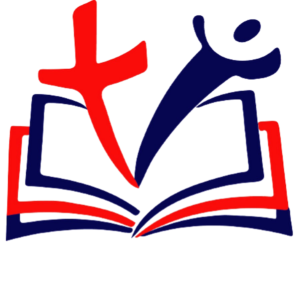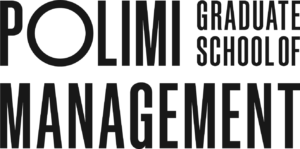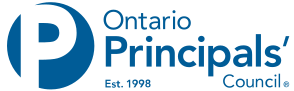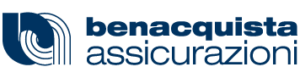Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Filomena Zamboli
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
La svolta dell’intelligenza naturale nell’educazione. Il “di più” di un’esperienza culturale viva di Dario Nicoli
Professional learning: making time for collaboration di Christopher Bezzina
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Per l’innovazione dei percorsi tecnici e professionali. Descrittori e leve di Stefano Versari
Dirigere la scuola: verso quali direzioni? di Annalisa Sannino
Governare l’artificiale con l’umano di Giuliano Bocchia
Recensione del libro di Paolo Benanti “La Grande Invenzione” di Giuliano Fasani
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Intelligenze in rete di Maria Paola Iaquinta
Sperimentazione di filiera tecnico professionale di Ezio Busetto
Intelligenza artificiale ed inclusione di Giovanni Minucci
Intelligenza naturale: una esperienza con studenti-artigiani e artisti di Benedetta Rostan
L’intelligenza artificiale: un’opportunità formativa nell’era dell’umanesimo tecnologico. Comunità di pratiche per la scuola italiana di Selenia Scinaldi
Intelligenza naturale e intelligenza artificiale: un’esperienza in atto di Roberto Pasolini
L’intelligenza artificiale: copilota instancabile nel brain-storming con i ragazzi di Antonella Lipardi
PARTE IV - CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DI OGGI
Le fonti normative del diritto scolastico di Mario Falanga
La governance della scuola: organi collegiali, capo d’istituto, autonomia. Confronto con la Francia, la Germania e l’Inghilterra di Ignazio Venzano
La sfida dell’intelligenza artificiale nell’istruzione tra etica, privacy e protezione dei dati di Ezio Montemurro
Editoriale
Questo è l’anno nel quale sembra esplosa la necessità di approfondire l’impatto
e le conseguenze, anche in educazione, della Intelligenza Artificiale. Era
nell’aria ed è legittimo analizzare una dimensione così pervasiva della nostra vita
quotidiana.
Noi della Rivista “Dirigere scuole” abbiamo pensato di affrontare la questione
da un’altra prospettiva, quella che riteniamo maggiormente adeguata alla
dimensione educativa e al governo della Scuola da parte dei Dirigenti scolastici.
La dimensione dell’intelligenza naturale
Scrive il Professor Nicoli, docente di Sociologia economica, dell’organizzazione
e del lavoro, che anche in educazione, serve una svolta naturale.
Tant’è che il pezzo di apertura di questo numero della rivista, a lui affidato,
titola: “La svolta dell’intelligenza naturale nell’educazione – Il “di più” di un’esperienza
culturale viva”.
È questo il filo rosso che lega gli articoli di questo numero, trattati da autori
esperti di esperienze e riflessioni sull’uso della IA e sul suo impiego scolastico e
di vita.
Essi mirano ad affrontare, innanzitutto, il concetto di intelligenza per poter
correttamente definire cosa sia “artificiale” e se l’utilizzo delle tecnologie, fino al
GPT-3, possano essere di supporto all’apprendimento e ai suoi percorsi. Abbiamo
desiderato focalizzare, innanzitutto, la domanda su cosa debba intendersi
con il termine intelligenza e come essa connoti la dimensione umana. Scopriamo,
così, che l’intelligenza è concetto non semplice da definire.
In ambito scientifico e psicologico, la concezione di intelligenza si è evoluta
nel tempo, passando da una originaria dimensione statica, quantitativa, cognitiva
e generale a una qualitativa, specifica e modulare. Da Howard Gardner in poi,
nel sentire pedagogico quotidiano, l’intelligenza non si riduce ad un’abilità intellettiva
generale, ma si configura come una competenza cognitiva complessa, connessa
con componenti sociali, emotive, pratiche e che consente di eseguire operazioni
mentali sofisticate, anche elaborando, integrando e organizzando dati.
Illuminante, tra gli altri, la recensione al testo del Professor Benanti “La grande
invenzione. Il linguaggio come tecnologia. Dalle pitture rupestri al GPT-3” a cura del dirigente
scolastico Fasani, in cui si ripercorre l’acuta riflessione del potere trasformativo
del linguaggio, visto come la grande invenzione che caratterizza l’uomo.
Il linguaggio è in se stesso una tecnologia, è un artefatto tecnologico. Quindi
anche la tecnologia è da collocarsi nell’ambito propriamente umano.
E qui traiamo la pista di riflessione, quella che ci interessa realmente, e cioè:
come si fa a mettere in moto i dinamismi naturali dell’intelligenza umana? E
come la tecnologia può essere utilizzata al loro servizio?
In una società sempre più affaticata nella relazione umana, la sola che avvia,
sostiene, accompagna e porta a compimento le dinamiche educative, da gente
impegnata seriamente con l’avventura dell’educazione non possiamo non ripartire
dalla provocazione della “Intelligenza”, la facoltà che, per natura, l’uomo
possiede ed è chiamato a sviluppare nelle sue dinamiche di interazione con il
mondo e i suoi stessi simili.
Per questo, la nostra Scuola, da sempre luogo dell’educazione viva, anziché
essere sommersa dalle opinioni e dal tecnicismo, sente il bisogno di raccogliere
la sfida e interrogarsi, per la Società e per il Bene, alla ricerca della umanità delle
persone che abitano i luoghi e i giorni di ogni anno scolastico. Riprendiamo,
perciò, qualche riga del Professor Nicoli:
La stagione delle innovazioni, che si è aperta, specie negli ultimi due decenni, ha portato
perlopiù ad esiti insoddisfacenti. Solo dopo la pandemia è emersa con maggiore chiarezza
la svolta profonda che sta trasformando il mondo dell’educazione, riassumibile nella
frase “mettere in vita la cultura”. Una prospettiva in cui alla scuola è richiesto di orchestrare
un’operazione culturale che coinvolga tutta la comunità educativa, dove la conoscenza
del mondo è vissuta come una ricerca condivisa, finalizzata a mettere in moto
i dinamismi naturali dell’intelligenza umana: curiosità, partecipazione, sensatezza,
operosità, esultanza. In tal modo si sollecitano gli studenti alla “scoperta esistenziale”
dell’identità come senso emergente dall’appartenenza a una realtà più grande dell’io
individuale, per cui valga la pena spendere le proprie energie, e della vocazione personale
come forza-passione che illumina ed alimenta il loro apporto creativo e fecondo alla
comunità.
Insomma, il pensiero critico non è solamente materia di speculazione. ma
abilità essenziale per ogni ragazzo che si appresta a crescere a ad affrontare le
sfide della vita.
In un’epoca, la nostra, in cui le informazioni sono tanto accessibili quanto
manipolabili, il pensiero naturale e, perciò, critico, rappresenta l’abilità fondamentale
da “ri-scoprire” perché sia posta al servizio di ogni essere umano.
Questo numero realizzato, come sempre, attraverso i contributi e il confronto
con rappresentanti del mondo accademico anche internazionale, esperti della
scuola e delle sue dinamiche di organizzazione e di gestione e le testimonianze
di Dirigenti e Docenti, cui mai rinunciamo per scelta vocazionale, impegnati nella
quotidianità didattica delle istituzioni scolastiche del Paese, rappresenta, ancora
una volta, un sentiero di riflessione e di sollecitazione. Perché mai possiamo restare
silenziosi dove la vita accade.
Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Filomena Zamboli
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
La svolta dell’intelligenza naturale nell’educazione. Il “di più” di un’esperienza culturale viva di Dario Nicoli
Professional learning: making time for collaboration di Christopher Bezzina
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Per l’innovazione dei percorsi tecnici e professionali. Descrittori e leve di Stefano Versari
Dirigere la scuola: verso quali direzioni? di Annalisa Sannino
Governare l’artificiale con l’umano di Giuliano Bocchia
Recensione del libro di Paolo Benanti “La Grande Invenzione” di Giuliano Fasani
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Intelligenze in rete di Maria Paola Iaquinta
Sperimentazione di filiera tecnico professionale di Ezio Busetto
Intelligenza artificiale ed inclusione di Giovanni Minucci
Intelligenza naturale: una esperienza con studenti-artigiani e artisti di Benedetta Rostan
L’intelligenza artificiale: un’opportunità formativa nell’era dell’umanesimo tecnologico. Comunità di pratiche per la scuola italiana di Selenia Scinaldi
Intelligenza naturale e intelligenza artificiale: un’esperienza in atto di Roberto Pasolini
L’intelligenza artificiale: copilota instancabile nel brain-storming con i ragazzi di Antonella Lipardi
PARTE IV - CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DI OGGI
Le fonti normative del diritto scolastico di Mario Falanga
La governance della scuola: organi collegiali, capo d’istituto, autonomia. Confronto con la Francia, la Germania e l’Inghilterra di Ignazio Venzano
La sfida dell’intelligenza artificiale nell’istruzione tra etica, privacy e protezione dei dati di Ezio Montemurro
Editoriale
Questo è l’anno nel quale sembra esplosa la necessità di approfondire l’impatto
e le conseguenze, anche in educazione, della Intelligenza Artificiale. Era
nell’aria ed è legittimo analizzare una dimensione così pervasiva della nostra vita
quotidiana.
Noi della Rivista “Dirigere scuole” abbiamo pensato di affrontare la questione
da un’altra prospettiva, quella che riteniamo maggiormente adeguata alla
dimensione educativa e al governo della Scuola da parte dei Dirigenti scolastici.
La dimensione dell’intelligenza naturale
Scrive il Professor Nicoli, docente di Sociologia economica, dell’organizzazione
e del lavoro, che anche in educazione, serve una svolta naturale.
Tant’è che il pezzo di apertura di questo numero della rivista, a lui affidato,
titola: “La svolta dell’intelligenza naturale nell’educazione – Il “di più” di un’esperienza
culturale viva”.
È questo il filo rosso che lega gli articoli di questo numero, trattati da autori
esperti di esperienze e riflessioni sull’uso della IA e sul suo impiego scolastico e
di vita.
Essi mirano ad affrontare, innanzitutto, il concetto di intelligenza per poter
correttamente definire cosa sia “artificiale” e se l’utilizzo delle tecnologie, fino al
GPT-3, possano essere di supporto all’apprendimento e ai suoi percorsi. Abbiamo
desiderato focalizzare, innanzitutto, la domanda su cosa debba intendersi
con il termine intelligenza e come essa connoti la dimensione umana. Scopriamo,
così, che l’intelligenza è concetto non semplice da definire.
In ambito scientifico e psicologico, la concezione di intelligenza si è evoluta
nel tempo, passando da una originaria dimensione statica, quantitativa, cognitiva
e generale a una qualitativa, specifica e modulare. Da Howard Gardner in poi,
nel sentire pedagogico quotidiano, l’intelligenza non si riduce ad un’abilità intellettiva
generale, ma si configura come una competenza cognitiva complessa, connessa
con componenti sociali, emotive, pratiche e che consente di eseguire operazioni
mentali sofisticate, anche elaborando, integrando e organizzando dati.
Illuminante, tra gli altri, la recensione al testo del Professor Benanti “La grande
invenzione. Il linguaggio come tecnologia. Dalle pitture rupestri al GPT-3” a cura del dirigente
scolastico Fasani, in cui si ripercorre l’acuta riflessione del potere trasformativo
del linguaggio, visto come la grande invenzione che caratterizza l’uomo.
Il linguaggio è in se stesso una tecnologia, è un artefatto tecnologico. Quindi
anche la tecnologia è da collocarsi nell’ambito propriamente umano.
E qui traiamo la pista di riflessione, quella che ci interessa realmente, e cioè:
come si fa a mettere in moto i dinamismi naturali dell’intelligenza umana? E
come la tecnologia può essere utilizzata al loro servizio?
In una società sempre più affaticata nella relazione umana, la sola che avvia,
sostiene, accompagna e porta a compimento le dinamiche educative, da gente
impegnata seriamente con l’avventura dell’educazione non possiamo non ripartire
dalla provocazione della “Intelligenza”, la facoltà che, per natura, l’uomo
possiede ed è chiamato a sviluppare nelle sue dinamiche di interazione con il
mondo e i suoi stessi simili.
Per questo, la nostra Scuola, da sempre luogo dell’educazione viva, anziché
essere sommersa dalle opinioni e dal tecnicismo, sente il bisogno di raccogliere
la sfida e interrogarsi, per la Società e per il Bene, alla ricerca della umanità delle
persone che abitano i luoghi e i giorni di ogni anno scolastico. Riprendiamo,
perciò, qualche riga del Professor Nicoli:
La stagione delle innovazioni, che si è aperta, specie negli ultimi due decenni, ha portato
perlopiù ad esiti insoddisfacenti. Solo dopo la pandemia è emersa con maggiore chiarezza
la svolta profonda che sta trasformando il mondo dell’educazione, riassumibile nella
frase “mettere in vita la cultura”. Una prospettiva in cui alla scuola è richiesto di orchestrare
un’operazione culturale che coinvolga tutta la comunità educativa, dove la conoscenza
del mondo è vissuta come una ricerca condivisa, finalizzata a mettere in moto
i dinamismi naturali dell’intelligenza umana: curiosità, partecipazione, sensatezza,
operosità, esultanza. In tal modo si sollecitano gli studenti alla “scoperta esistenziale”
dell’identità come senso emergente dall’appartenenza a una realtà più grande dell’io
individuale, per cui valga la pena spendere le proprie energie, e della vocazione personale
come forza-passione che illumina ed alimenta il loro apporto creativo e fecondo alla
comunità.
Insomma, il pensiero critico non è solamente materia di speculazione. ma
abilità essenziale per ogni ragazzo che si appresta a crescere a ad affrontare le
sfide della vita.
In un’epoca, la nostra, in cui le informazioni sono tanto accessibili quanto
manipolabili, il pensiero naturale e, perciò, critico, rappresenta l’abilità fondamentale
da “ri-scoprire” perché sia posta al servizio di ogni essere umano.
Questo numero realizzato, come sempre, attraverso i contributi e il confronto
con rappresentanti del mondo accademico anche internazionale, esperti della
scuola e delle sue dinamiche di organizzazione e di gestione e le testimonianze
di Dirigenti e Docenti, cui mai rinunciamo per scelta vocazionale, impegnati nella
quotidianità didattica delle istituzioni scolastiche del Paese, rappresenta, ancora
una volta, un sentiero di riflessione e di sollecitazione. Perché mai possiamo restare
silenziosi dove la vita accade.