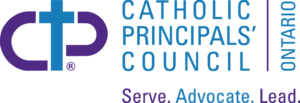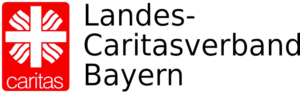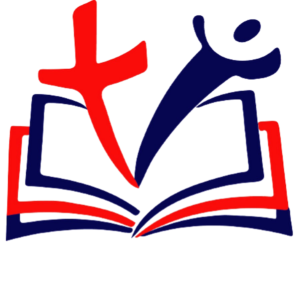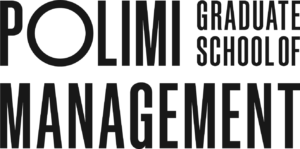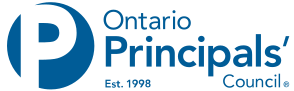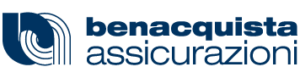Articolo di Direzione DiSAL
La Direzione Nazionale DiSAL propone una riflessione sul Documento Nuove Indicazioni Nazionali.
Materiali per il dibattito pubblico
- Visioni
Chiavi di lettura
La vera novità che le Indicazioni possono portare al Sistema scolastico italiano si identifica:
- nel rilancio del ruolo dell’autonomia scolastica di cui esse sono figlie ed espressione
- nella legittimazione del curricolo, che implica il riconoscimento della professionalità dei docenti e dei dirigenti, chiamati non più ad essere gli esecutori dei Programmi (che sono oggetti da applicare), ma ricercatori, capaci di visione, di progettualità e di azioni in sinergia con altri docenti.
DiSAL analizza il Documento predisposto dalla Commissione utilizzando le seguenti chiavi di lettura:
→ le Nuove I.N. rispondono alle esigenze e alle complessità formative, culturali e sociali dell’attuale momento storico?
→ le Nuove I.N. valorizzano la responsabilità professionale dei docenti e la capacità progettuale delle scuole, per tradurre gli orientamenti ministeriali nei modi che riterranno più opportuni, coerenti ed efficaci?
Quale cultura
Una revisione delle I.N. è sempre una operazione culturale e non solo un intervento di manutenzione. La questione culturale implica il vivere ed il significato che si attribuisce alla esperienza del vivere: il sapere di saggezza non è rinchiuso entro uno spazio di meri “insegnamenti”, perchè il vero apprendimento implica sempre la risposta ad un problema, esplicito o implicito, che il docente fa emergere negli alunni. Si tratta di un’operazione culturale che si avvale della fecondità del dialogo tra le generazioni
→ Le Nuove I.N. consentano agli insegnanti ed alle scuole di realizzare occasioni di conoscenza viva
e non standardizzata?
Ruolo del responsabile di scuola
Le Nuove I.N. devono tenere conto del ruolo del dirigente scolastico e del coordinatore didattico i quali, nel loro compito di dare attuazione alle stesse I.N., devono:
– essere messi in grado di sostenere ed attuare procedure e progettazioni finalizzate ad aiutare i docenti a contestualizzare la proposta didattica e culturale disciplinare e di istituto rispetto ai bisogni formativi degli studenti e dei territori di riferimento:
– essere messi in grado di valorizzare e di consentire ai docenti la traduzione delle Indicazioni nazionali nel pieno esercizio della libertà di insegnamento e di educazione;
– essere messi in grado di interpretare il contesto scuola come spazio di soggettività professionale, di esercizio della progettualità collegiale e della relazione con i territori.
- Osservazioni sulla “Premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni”
Lunghezza dell’estensione
La lunghezza del documento appare eccessiva. Alcuni temi richiamati dal testo sono già ampiamente presenti nelle normative a cui è sufficiente fare riferimento (v. il tema dell’inclusione, della valutazione ,ecc.) e sono patrimonio comune dei docenti e dei gruppi di lavoro delle scuole.
→ Nella revisione si auspica una significativa riduzione del testo
Contesto
L’articolato della “Premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni” non legge nè interpreta pienamente le esigenze e le complessità formative, culturali e sociali del mutato contesto in cui la scuola italiana oggi si trova ad operare, caratterizzato – soprattutto nel I ciclo – anche dall’alto numero di studenti neo-arrivati o di recente immigrazione, con problemi linguistici( si veda lo sviluppo significativo della didattica dell’italiano come L2) e da quanto la pandemia ha drammaticamente modificato nelle dinamiche psicologiche, relazionali e cognitive
→ Nella revisione della “Premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni” integrare i riferimenti ai nuovi contesti culturali, sociali e cognitivi
Riferimenti alla ricerca metodologico-didattica
Rispetto alle attuali Indicazioni nazionali del 2012, non si evince nella “Premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni” quali siano le matrici metodologiche e didattiche di riferimento proposte a chi dovrà interpretarne l’applicazione (Morin, Bruner, Vigotskij…)
Molti termini sembrano fare riferimento ad un modello di personalismo (persona, inclusione, magis,…), ma appaiono generici, non sono indicazioni metodologiche di lavoro,
→ Evidenziare maggiormente alcune referenze di tipo metodologico e didattico tralasciando il linguaggio “pedagogese”, evitando idealismi inopportuni
Il contributo delle neuroscienze
Non vi è riferimento nella “Premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni” alle scoperte ed al contributo delle neuroscienze, contributo imprescindibnile per la didattica:
- l’insegnamento può acquisire più efficacia attraverso la comprensione dei processi neurali;
- la fisiologia celebrale può aiutare a comprendere cambiamenti generazionali;
- valorizzazione della sinergia tra neuroscienze, pedagogia e progettazione didattica.
→ Evidenziare quali tra le evidenze degli studi delle neuroscienze possano aiutare nella lettura dei bisogni formativi e come le discipline possano corrispondervi
- Quale curricolo, per quale alunno, per quale società
Quale scuola
L’impianto della proposta delle Nuove I.N. sembra voler guardare ad una scuola del passato e rimandare a una logica più vicina ai programmi che non agli orientamenti pensati per una scuola del XXI secolo. La definizione della natura della scuola nel contesto attuale e l’individuazione di un suo modello devono tradursi in:
– un curricolo (che è il suo principale strumento di lavoro)
– uno sguardo sull’alunno (che è il destinatario di tutta l’azione educativa)
– un’attenzione ai cambiamenti della società (che è l’orizzonte sul quale ci si muove)
La considerazione attenta di questi tre elementi consente di sfuggire all’autoreferenzialità della riflessione che la scuola può condurre su se stessa.
Cultura, Scuola, Persona
Nelle Indicazioni 2012 il paragrafo ‘Cultura, Scuola, Persona’ esprimeva con immediatezza l’idea che la scuola aiuta la persona a realizzarsi tramite la cultura: non è chiaro, invece, quale è il messaggio di ‘Persona, Scuola, Famiglia’ nella “Premessa culturale delle Nuove Indicazioni”. Oggi è difficile trovare nella realtà della società la famiglia descritta nelle Nuove I.N.: spesso le scuole hanno a che fare con fragilità genitoriali se non con l’assenza della famiglia e con una distanza culturale con i genitori che pone domande nuove alla scuola.
Lo scenario culturale attuale nel quale occorre contestualizzare le Nuove Indicazioni nazionali è, invece, ancora quello già prefigurato dalle I.N. 2012 sintetizzate nel titolo “Cultura, scuola, persona”che rimanda ai segni della pluralità (di esperienze, di culture, di ambienti di apprendimento, di scenari lavorativi), da affrontare con un necessario atteggiamento di apertura (nei confronti della diversità, dell’innovazione, delle tecnologie) e di consapevolezza (delle domande di senso, dei valori di riferimento, delle responsabilità educative).
→ recuperare il titolo “Cultura, Scuola, Persona” e il relativo impianto.
Centralità della persona
Del testo della “Premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni” apprezziamo il richiamo alla centralità della persona e al principio della personalizzazione, da rileggere come scoperta delle radici insopprimibili dell’essere umano quale soggetto in perenne relazione con sé e con l’altro da sé.
A questa istanza essenzialmente antropologica e pedagogica si deve affiancare la costruzione della cittadinanza.
→ Recuperare e potenziare nella Premessa gli sfondi culturali della personalizzazione e della cittadinanza
- Osservazioni sul capitolo “Discipline”
Nuclei fondanti delle discipline
Si propone alla Commissione di evidenziare meglio i “nuclei del sapere” che la scuola è chiamata a fornire ai giovani per la loro formazione, in quanto:
– possiedono un valore strutturante e generativo di conoscenze
– mobilitano le capacità cognitive, strutturano il ragionamento e la capacità decisionale
– orientano la scelta dei contenuti prioritari dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Si propone alla Commissione di evidenziare maggiormente i nuclei fondanti delle diverse discipline perché essi:
- possiedono uno statuto epistemologico riguardante un dominio, una metodologia ed un
linguaggio;
- forniscono un orizzonte di senso;
- presentano una rilevanza sociale e storica;
- possiedono una valenza formativa.
Si propone alla Commissione di avviare un ulteriore approfondimento di due aspetti ‘pratici’ direttamente connessi con i nuclei fondanti:
- la necessità di individuare nella descrizione delle Discipline dei contenuti minimi essenziali per ogni materia (sia al termine di ciascun ciclo di istruzione, sia nella articolazione degli anni di studio) e contemporaneamente di definire dei traguardi di competenze essenziali ben definiti;
- i contenuti minimi e i traguardi di competenze devono essere i nuovi parametri per effettuare le valutazioni periodiche e finali degli alunni delle diverse classi e per le rilevazioni INVALSI, andando di fatto ad interagire con quanto si indica nel D.lgs. 62/2017.
Esempi di moduli disciplinari
Disal propone di eliminare nelle parti relative alle diverse Discipline i paragrafi intitolati ‘Esempi di moduli disciplinari di apprendimento’ e ‘Ibridazioni tecnologiche’ che rischiano di rappresentare proposte parziali, seppur valide, o, per altri versi, vincolanti e non rispettose della libertà progettuale e culturale di chi è chiamato a scrivere nelle scuole curricoli di istituto e di classe. Le IN non hanno il compito di formare i docenti esemplificando e modellizzando le modalità di utilizzo dei contenuti disciplinari: il sostegno alla formazione metodologico-didattica dei docenti deve essere altrimenti sostenuta in ingresso e in itinere attraverso altri percorsi e strumenti.
Titoli
Si propone di modificare il registro di carattere epistemologico dei paragrafi titolati, ad esempio, “Perché si studia l’italiano”, “Perché si studia il latino” in quanto rappresentano un tono tra il prospettico e il didascalico che poco si addice ai professionisti della scuola che hanno consapevolezza di come interpretare in chiave epistemologica e metodologica la propria disciplina.
Sezioni
DiSAL ritiene positive ed interessanti:
- la sezione dedicata alla scuola dell’infanzia a cui si dà (finalmente) uno spazio ampio riconoscendone maggiormente il valore;
- le sezioni indirizzate alla didattica delle lingue straniere, delle scienze motorie (molto sobria ma anche molto ricca di spunti interessanti), quella musicale;
- gli allegati di carattere internazionale.
Proposta di integrazioni
Educazione Civica
È necessario inserire un paragrafo dedicato all’insegnamento dell’Ed. Civica come ambito in grado di sviluppare negli alunni la partecipazione attiva alla vita del Paese, anche in relazione al rapporto con l’ambiente e alle competenze digitali.
Orientamento
Si ritiene sia da evidenziare il tema dell’orientamento alla scuola sia con uno specifico paragrafo che come tema diffuso nei paragrafi relativi alle Discipline.
Valutazione
Ci saremmo attesi un approfondimento degli aspetti relativi alla valutazione, anche in collaborazione con l’INVALSI e gli altri istituti europei e un richiamo esplicito a quanto si sta facendo nelle scuole anche grazie ai fondi del PNRR, che nei casi più illuminati stanno modificando profondamente la didattica quotidiana. La parte valutativa finale è poco sostanziata, si apprezza comunque il richiamo alla collegialità e alla valutazione come strumento per l’orientamento.
Connessioni
Si suggerisce alla Commissione di rendere sinergico il percorso di elaborazione delle Nuove I.N. con il lavoro di confronto ed elaborazione che sta svolgendo la Scuola di Alta Formazione per la scrittura dei framework delle diverse figure professionali della scuola ( in particolare dei dirigenti scolastici e dei docenti) e con i risultati e le evidenze della ricerca svolta in questi anni da Invalsi.
Milano, 26 marzo 2025
La Direzione nazionale DiSAL