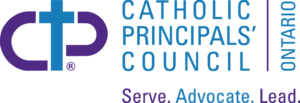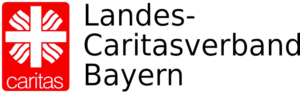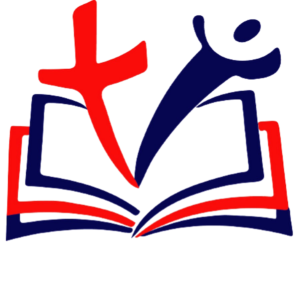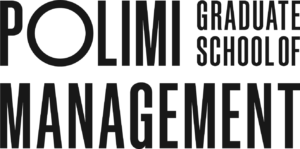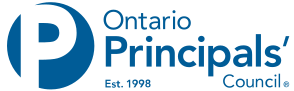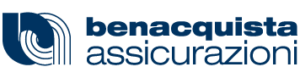Fonte: Tempi - 30 aprile 2025
Articolo di Caterina Giojelli
La legge che doveva dare corpo alla libertà educativa in Italia ha compiuto 25 anni, ma per le famiglie che la esercitano «siamo ancora all’elemosina di Stato». Roberto Pasolini, uno dei leader del movimento che ottenne quella riforma, ci spiega perché è il momento di tornare alla carica
«Dov’è finito il popolo della parità scolastica? È diventato il popolo della rassegnazione? Il contrasto ideologico è sempre esistito: l’11 dicembre 1999, 50 mila persone sfilarono a Roma contro l’approvazione la legge di parità in discussione al Parlamento. Ma in 200 mila eravamo in piazza San Pietro davanti a Giovanni Paolo II a gridare: “Libertà!”. E ventimila, tre anni prima, al Palavobis di Milano, tra studenti, genitori e insegnanti, chiedevano una legge di parità per avere il diritto alla libertà di scelta educativa. La domanda è: ci crediamo ancora? Siamo pronti a difendere il diritto dei meno abbienti di scegliere la scuola per i propri figli? Altrimenti, per le paritarie la sopravvivenza è solo questione di tempo».
Roberto Pasolini, rettore dell’Istituto Europeo Leopardi a Milano, si sente ringiovanito di trent’anni, tanti quanti ne sono passati da quando, con un manipolo di colleghi e l’ex ministro Mario Mauro (allora professore a capo di una serie di sigle del mondo della scuola), animò un enorme movimento che chiedeva al Parlamento una legge di parità. Quel movimento portò al grande incontro al Palavobis, alla riforma Berlinguer e alla legge 62/2000 sulla parità scolastica. Dopo 25 anni, la legge è rimasta praticamente lettera morta e per Pasolini è giunta l’ora di tornare in piazza, «o almeno a palazzo. Il convegno in Regione Lombardia del 24 marzo, “25 anni di legge di parità e dote scuola: dare compimento alla libertà educativa”, vuole essere un segnale per svegliare chi si è rassegnato all’elemosina dello Stato, tra promesse di aiuti finanziari alle famiglie mai mantenute. Il contributo ordinario è fermo da 15 anni a circa 500 milioni di euro, ma con l’inflazione ha perso il 40 per cento del potere d’acquisto. Non possiamo continuare così per altri 25 anni, rischiamo l’estinzione».
Cosa si deve fare?
Innanzitutto, recuperare il positivo confronto con la politica che portò alla legge 62: il sostegno alle paritarie non è una concessione, ma un diritto sancito dalla Costituzione, i politici devono guadagnarsi il consenso delle famiglie. E non è solo una questione di giustizia, ma anche di convenienza economica per lo Stato: la parità paga, sostenere le famiglie che scelgono la scuola paritaria costa meno che finanziare l’istruzione statale per gli stessi studenti. Le simulazioni economiche già condotte anni fa con Tommaso Agasisti e Luisa Ribolzi lo dimostrano chiaramente. Il problema, dunque, non è economico, ma politico. La politica dovrebbe rimuovere gli ostacoli economici affinché tutti i cittadini possano usufruire delle stesse opportunità, come quella di avere per otto anni l’istruzione gratuita, così come prevede la Costituzione.
Pensa di inserire il finanziamento diretto alle scuole nella Carta?
No, dal mio punto di vista la Carta parla chiaro. Se si leggono gli atti della Costituente, il cosiddetto emendamento Corbino si riferisce a oneri per l’istituzione ma non nega come avvenuto contributi ordinari, ma ritengo che fondamentalmente gli articoli della Costituzione sanciscono che i finanziamenti vadano prioritariamente alle famiglie. Il diritto alla libertà di scelta educativa appartiene alle famiglie. Stiamo svolgendo e presenteremo una ricerca sulla dote scuola in Lombardia per dimostrare l’importanza di un sostegno diretto ai genitori. Venticinque anni fa chiedevamo una legge, oggi chiediamo il rispetto delle norme in vigore: gli articoli della Costituzione numero 30, 31, 33, 34, l’articolo 3, l’articolo 118, la legge 62/2000, le sentenze della Corte costituzionale (42/2002 e 33/2005), la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) e la Convenzione sui diritti del bambino, articoli 18-28-29. Non c’è niente da inventare: è sconcertante leggere tutte assieme queste norme, sconcertante perché sono norme esistenti, ma non applicate.
«Sconcertante» è stato il commento più gentile del M5s all’emendamento Malagola e all’apertura del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a un buono scuola nazionale: si toglie ai poveri per dare ai ricchi, si è ripetuto da Avs al Pd, si penalizza «la scuola statale, nazionale e laica», in favore di quella «privata».
Fake news: i “soldi” non vanno ai ricchi, ma ai poveri, i meno abbienti. Quando sono stati stanziati 50 milioni per il sostegno agli alunni con disabilità nelle paritarie, si è detto che si toglievano risorse alla scuola statale: altra fake news, i “soldi” aiutano le famiglie, coprendo solo in parte (e abbiamo dovuto battagliare anni per arrivare al 60-70 per cento) i costi per il sostegno, che, invece, è gratuito nella scuola statale.
L’impressione però è che, mentre gli slogan anni Settanta contro le paritarie resistono, anche tra gli studenti che oggi bruciano i fantocci del ministro, la lotta per la libertà educativa sembra essersi spostata da una piazza popolare agli specialisti.
Il contesto è cambiato. A dicembre ho pubblicato un articolo sul Sussidiario, “Paritarie in estinzione, dove sono gli ideali di libertà che hanno sorretto un popolo?”. È stato un masso nello stagno, che ha portato a una reazione delle associazioni con l’elaborazione del documento per il rilancio del diritto civile alla libertà di scelta educativa e al convegno in Lombardia promosso da 24 sigle. Nel mezzo tanti confronti e anche autocritiche. Oggi molte famiglie, purtroppo, non percepiscono l’urgenza della battaglia per la libertà di educazione come una questione di equità sociale. In molte zone di Milano, ad esempio, la presenza di scuole statali con un’alta concentrazione di studenti stranieri spinge anche le famiglie progressiste verso le paritarie, ma non per ideali, bensì per garantire ai figli una migliore istruzione. Tuttavia, se la scuola paritaria diventa un’opzione solo per chi “ha i soldi”, si perde il significato di parità e il sistema corre gravi rischi.
Quali sono i rischi?
Un sistema scolastico sostanzialmente monopolistico, con la sola presenza della scuola statale, delle scuole italiane acquisite da network stranieri internazionali con rette oltre i 15 mila euro annui (più del doppio del costo medio indicato dal Mef) e di scuole paritarie capaci di offrire un servizio pubblico di alta qualità a rette di frequenza elevate, necessarie per garantirne la gestione (anche superiori al costo medio indicato dal Mef di circa 8 mila euro, nelle grandi città), ma non potranno più essere “paritarie” perché riservate, inevitabilmente, solo a una classe sociale medio alta: quante famiglie potranno permetterselo? L’assenza di pluralismo educativo, inoltre, porta all’omologazione culturale e all’esclusione sociale. Non a caso il primo passo dopo la caduta di un regime totalitario è l’apertura di scuole libere che alzano il livello culturale e la capacità critica degli studenti.
Nei paesi più avanzati sotto il profilo dell’istruzione si sta andando proprio nella direzione opposta.
Negli Stati Uniti, le “charter school” hanno riqualificato territori a rischio e portato l’istruzione a chi non ne aveva accesso grazie a un sistema che garantisce autonomia e libertà di scelta. In Inghilterra le “academy school” istituite da Tony Blair hanno migliorato il sistema scolastico grazie a un modello di finanziamento indipendente e gestione privata, mantenuto e completato anche dai governi successivi pur di colore politico diverso come quello di Cameron. In Italia, purtroppo, questa buona pratica politica non è seguita, salvo rare eccezioni come il passaggio della responsabilità di ministro da Fioroni a Gelmini, e ogni nuovo ministro di colore politico diverso tende a cancellare le riforme del predecessore.