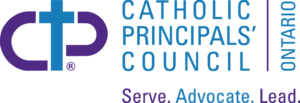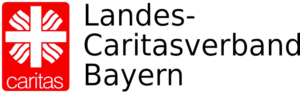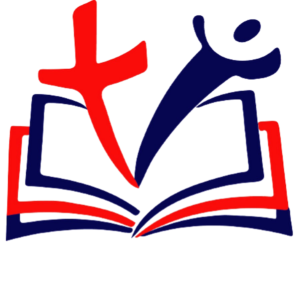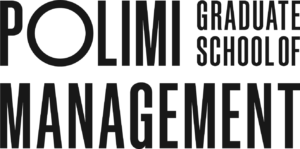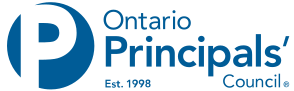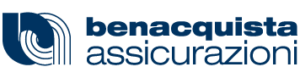Fonte: Il sussidiario.net
Articolo di Maria Grazia Fornaroli
Educazione sessuale e civica a scuola: se lo Stato dà la possibilità di non frequentare i corsi rischia di precludere delle opportunità agli studenti
La scuola, non ci stanchiamo di ripeterlo, è in una profonda crisi e non avrebbe bisogno di essere oggetto di ulteriori stress, ma se mai di ricevere dalla politica più stima. Le iniziative di questi ultimi giorni invece saranno (e lo sono già state) foriere di profonde tensioni. Già le nuove Indicazioni 2025 per la primaria e la secondaria di primo grado sono tuttora oggetto di numerose critiche; il ministero ha ritenuto prioritario, a fine anno, emanare ulteriori documenti.
Questo per ogni scuola è un tempo delicato e prezioso: manca una quindicina di giorni effettivi alla chiusura d’anno, dedicati alle valutazioni (coerenti come in ogni organizzazione a quanto è stato programmato a inizio d’anno), di norma un periodo orientato alle gioiose e talora ancora molto significative esperienze di performances delle ricchissime attività cosiddette extracurriculari, che tuttavia in molti casi per studenti e genitori sono quanto di più significativo rimarrà nel tempo come ricordo indelebile dell’esperienza scolastica.
In questo quadro, la nota ministeriale sulla necessità di evitare valutazioni eccessivamente concentrate, nota di buon senso, da un lato pleonastica nelle scuole nelle quali da anni si lavora per una valutazione formativa, in altre, meno attente alla questione, è stata sentita come un’ingerenza indebita alla libertà di insegnamento.
La valutazione, i lettori di questa pagine lo sanno bene, è un aspetto cruciale del sistema, ma tuttora stenta a decollare come questione fondativa. La nota ministeriale fornisce sì un assist a qualche dirigente per proporre (non imporre) una valutazione più coordinata tra i docenti, ma certo tempi e stile del documento risultano poco coerenti ai reali bisogni del contesto.
Veniamo alle ultime novità in fatto di inasprimento dei reati di violenza nei confronti del personale scolastico, di eliminazione della carriera alias e di necessità di consenso per le attività di educazione civica e sessuale.
Nulla da eccepire, nella prospettiva di aumentare la stima sociale per l’istituzione scolastica, sull’inasprimento delle pene per i violenti. Per le altre proposte stupisce innanzi tutto la tempistica. Inoltre il rischio che si intravvede è quello che, soprattutto nella scuola statale, queste tematiche inaspriscano il conflitto oppure che siano al momento trascurate.
Lasciamo da parte per il momento il tema “carriera alias”, drammatico e necessariamente molto complesso per cui attendiamo altre occasioni per confrontarci. Basti rimarcare che la scelta di molti dirigenti scolastici negli ultimi anni di accogliere talora in modo automatico la richiesta dei genitori di modificare sui registri scolastici l’identità del minore è apparsa se non altro precipitosa. Meglio aspettare la maggiore età dello studente e continuare a lavorare per costruire nella scuola un clima di rispetto.
Quello che appare oggi invece fortemente discutibile è la questione della possibilità da parte dei genitori di dare più o meno consenso alle attività di educazione civica e di educazione sessuale. Vero è che si darebbe applicazione alla nota ministeriale 19354 del 2018, ma è anche vero che visto il recente e drammatico contesto che le nostre società si sono trovate ad attraversare, la nota era forse stata trascurata. Consenso dei genitori ad attività progettate dai collegi dei docenti, inserite nel documento programmatico dell’offerta formativa? Dove finisce il patto di fiducia formalizzato nell’iscrizione? E l’autonomia dei collegi dei docenti? Qual è la ratio? Si tratterebbe, a detta del legislatore, di tematiche fortemente orientate alla libertà di coscienza delle famiglie.
In una società in cui la maggior parte dei nostri adolescenti vive ormai in contesti familiari mutilati e muti e trascorre la maggior parte delle ore extrascolastiche di fronte a schermi dove la violenza, di natura sessuale e non, la fa da padrona, vogliamo consentire che l’educazione civica e quella sessuale diventino a scuola opzionali? L’opzionalità nella scuola italiana (lo sappiamo bene dalla triste storia dell’opzionalità all’insegnamento della religione cattolica) si traduce per lo più in ore di abbandono o di autogestione.
Invece di introdurre norme più certe in occasione dell’attribuzione a enti esterni della gestione di queste attività, di prevedere la presenza del docente di classe accanto all’operatore, di valutare l’inserimento di moduli dedicati in alcune discipline già inserite nel curriculum, di offrire alle scuole la possibilità di confrontarsi con progetti di qualità, invece di tutto questo si preferisce consentire ai genitori di escludere l’adolescente da un paragone, molto delicato, non lo neghiamo, con tematiche presentissime nel suo vissuto.
Quali saranno i genitori che, in scienza e coscienza, non apporranno l’autorizzazione? Non si rischia di precludere l’approfondimento di queste tematiche proprio a ragazzi che hanno alle spalle contesti familiari debolissimi (penso soprattutto ai neoimmigrati) e che spesso si sostituiscono ai genitori nella gestione della burocrazia scolastica?
”Un’ora in meno di scuola è sempre preferibile. Chattiamo in libertà fuori dalla classe”, questo lo scenario prevedibile.
Nella maggior parte degli istituti, da tempo le commissioni che si occupano dei cosiddetti “Progetti Salute” prevedono la compresenza di genitori e, nelle superiori, anche degli studenti. È questo il luogo dell’attenta disamina delle proposte, dei contenuti e dei metodi proposti dagli enti e dalle associazioni; questo è il luogo del confronto, anche acceso, prima che il progetto sia poi presentato per la definitiva approvazione nei collegi dei docenti e nel consiglio di istituto, organo questo paritetico, giuridicamente deputati alla validazione dell’offerta formativa.
Il timore che queste attività presentino un alto contenuto ideologico è comprensibile, ma il timore non dovrebbe comportare la rinuncia alla partecipazione alle attività. Questo appare sinceramente come un atteggiamento vanamente conflittuale e piuttosto pavido. Potrebbe addirittura configurarsi come una riduzione del diritto allo studio e come indebita ingerenza dei genitori nell’alveo della progettazione didattica-formativa.
Si vuole porre l’attenzione sull’evidenza che qualsiasi ora di lezione, si pensi alla filosofia, all’arte, alle scienze, possa essere, soprattutto nella scuola di Stato, un’occasione in cui lo studente incontra proposte non in linea con i valori espressi in famiglia; ma il dialogo con gli adulti, il confronto, appaiono la strada maestra dell’apertura leale alla realtà. A meno evidentemente di contenuti espressamente fuori legge, ma questa è un’altra storia.
La possibilità offerta alle famiglie di rinunciare a quanto la scuola offre appare una sconfitta per entrambi i fronti. La possibilità di rinunciare alle lezioni di educazione civica, disciplina sicuramente ad alto rischio ideologico, ma foriera di interessanti sviluppi e innovazioni, appare oltremodo anacronistica.
La categoria della cittadinanza, pur con le sue problematicità, ci appare come disciplina fondativa della formazione, soprattutto nel nostro Paese in cui la dimensione “politica” della vita appare sempre meno interessante. È auspicabile che il dibattito in Parlamento sia l’occasione per una riflessione responsabile nella prospettiva di soluzioni più convincenti e rispondenti alla realtà del bisogno formativo dei nostri ragazzi, in un orizzonte di alleanze educative e non di sterili scontri.