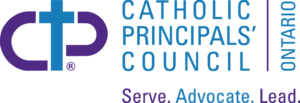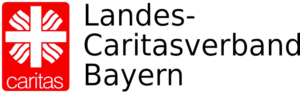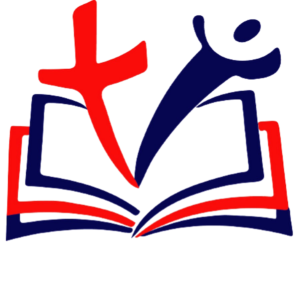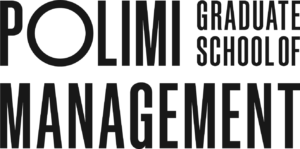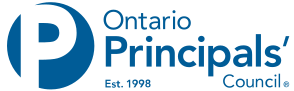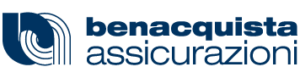Articolo di Giuliano Fasani

Al liceo Fermi di Padova lo scorso 27 giugno Gian Maria Favaretto si è rifiutato di sostenere il colloquio orale dell’esame di Stato ed è stato comunque promosso perché la somma dei crediti scolastici e il punteggio delle prove scritte lo hanno portato oltre i 60 punti. “Ho cercato di seguire le regole e ad affrontare la scuola come gli altri, ma non ero a mio agio”, questa in sintesi la sua posizione riportata dal Corriere della Sera.
Il ministro Valditara è intervenuto tempestivamente annunciando una modifica normativa che impedirà il “boicottaggio” del colloquio, ha infatti dichiarato al Corriere: “Con questa norma voglio dare un forte messaggio in linea con la Costituzione. C’è un problema importante nella società italiana ed è il rapporto con la regola. Troppo spesso non è chiaro che la regola si rispetta, così come si rispettano le persone”.
Al rifiuto di Favaretto sono seguiti diversi episodi di rifiuto del colloquio orale da parte di altri studenti.
L’anno scorso aveva già fatto un certo scalpore il rifiuto di tre studentesse del Liceo Foscarini di Venezia di sostenere il colloquio orale perché contestavano la valutazione insufficiente della commissione nella prova di greco. Insieme a loro erano risultati insufficienti 10 studenti su 14 della medesima classe. Già allora il ministro aveva annunciato una modifica normativa.
Federico Pichetto e Eraldo Affinati sono intervenuti su questo tema. Facendo clic sui rispettivi nomi è possibile recuperarne i testi.
Il dibattito sull’argomento si è allargato con il contributo di diversi soci Disal, che qui viene liberamente riassunto.
Una prima posizione evidenzia come la contestazione giovanile del colloquio colga meglio l’essenza del processo educativo di quanto invece sembri supporre il ministro. I giovani infatti evidenziano che la personalità e l’umanità, nei suoi aspetti più profondi e veri, è insondabile, in accordo con alcuni grandi educatori moderni. Il ministro cadrebbe perciò in una trappola ideologica.
Una seconda posizione sottolinea come la contestazione degli studenti, se fosse coerente, non dovrebbe riguardare solo una parte dell’esame, cioè il colloquio, ma l’intero esame che perciò sarebbe necessariamente coinvolto.
Un terzo punto di vista condivide la posizione del ministro e sostiene che il rifiuto del colloquio, essendo una parte essenziale dell’esame, denota una mancanza di serietà e di maturità da parte degli studenti.
Un quarto punto di vista, in sintonia con il primo, condivide essenzialmente le tesi espresse da Pichetto e Affinati e ritiene che il rifiuto del colloquio sia la conferma di un disagio profondo vissuto dai giovani e testimoni quanto sia attuale l’”emergenza educativa” già evocata da Papa Francesco.
Il compito degli educatori è di aprire un dialogo con i giovani per ascoltare con simpatia e attenzione disagi, domande e richieste.
La scuola deve essere un luogo di vita, pieno di significato in cui sia possibile gustare la vita e la cultura. Occorre ricostruire il nesso tra apprendimento e vita reale.
C’è una larga fascia giovanile che non avendo alle spalle una famiglia e degli educatori che li aiutino ad affrontare la realtà, si trova in estrema difficoltà nella complessità delle sfide attuali e spesso la scuola non riesce ad intercettare questi vasti bisogni educativi ed umani.
Un quinto punto di vista ritiene che dietro al rifiuto del colloquio ci sia la rinuncia ad affrontare le difficoltà e le asprezze della vita, quindi la posizione dei giovani contestatori sarebbe una posizione di comodo.
Un sesto punto di vista ritiene che l’accento debba essere posto sulla libertà e sulla regola. Secondo San Benedetto la regola non è un ostacolo ma un aiuto alla realizzazione di sé. Mentre l’obbedienza porta alla costruzione del sé, il fare ciò che pare e piace non produce frutti.
La società scolastica nel suo insieme deve poi stare alle regole.
Occorre mantenere sempre aperto il dialogo con gli studenti, in accordo con il quarto pdv. Il colloquio d’esame è un’occasione importante per stabilire un dialogo.
In accordo con il secondo pdv, se si rifiuta il colloquio occorrerebbe rifiutare l’intero esame.
L’esame non consiste solo nel colloquio.
Bisognerebbe portare particolare attenzione alle seconde prove che in alcuni casi non sono coerenti con il Pecup perché troppo contenutistiche, mentre in altri casi lo sono e riescono a far emergere le competenze e i talenti degli studenti.
Occorrerebbe inoltre rivedere i documenti di preparazione dell’esame, per esempio il documento del 15 maggio per renderlo maggiormente “dialogante”.
Un settimo pdv sottolinea l’importanza di tutto il percorso scolastico svolto precedentemente e in vista dell’esame con la connessa responsabilità degli adulti che hanno accompagnato gli studenti.
Un ottavo pdv ritiene che le regole attuali siano figlie di un’impostazione militaresca. Occorre perciò ripensare le regole e le relazioni che si stabiliscono all’interno della scuola. È necessario poi pensare anche a nuovi strumenti e procedure che vanno sognate, progettate e costruite con cura e coscienza.
Un nono pdv propone come esemplare il sistema inglese concepito come dialettica tra evaluation e assessment.
Un decimo pdv in accordo con il primo e il quarto pone l’accento sulla costruzione di relazioni autentiche all’interno dell’ambiente scolastico.
Un undicesimo pdv condivide le tesi di Pichetto e Affinati e ritiene che il colloquio d’esame non possa essere il luogo adeguato per verificare la responsabilità, l’autonomia e la maturità, come invece ritiene il ministro.
Per poter verificare queste competenze “forti”, oggi alcune di esse vengono definite “soft skills”, occorre un rapporto educativo stabile nel tempo. Sono quindi gli insegnanti di classe che possono valutare una parte importante del Pecup.
Per verificare conoscenze e competenze disciplinari, che all’esame vengono valutate nelle prove scritte e anche nel colloquio, sarebbe invece più opportuno utilizzare dei test oggettivi o sottoporre le prove ad una commissione interamente esterna.
Questo pdv condivide in buona parte l’impostazione del sistema inglese evidenziata nel nono pdv.
Un dodicesimo pdv ritiene che l’esame attuale sia del tutto inadeguato e inutile, anche nel confronto con l’estero e propone come elemento importante di valutazione il portfolio dello studente.
Un tredicesimo pdv ritiene che occorra rilanciare la discussione sul valore legale del titolo di studio e dell’esame di stato con i suoi “riti e procedure”,
Un quattordicesimo pdv osserva come l’esame di stato sia previsto dalla Costituzione.
Un quindicesimo pdv nota che un tentativo di modifica dell’esame di stato fu fatto nel periodo del covid quando si diede maggior peso al colloquio rispetto alle prove scritte.