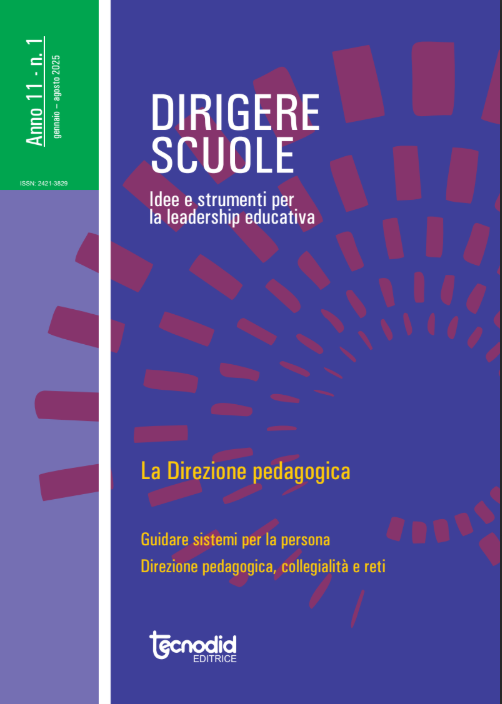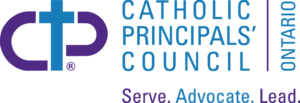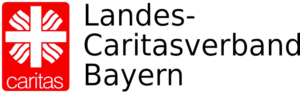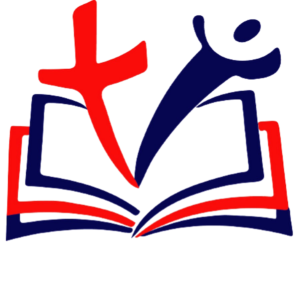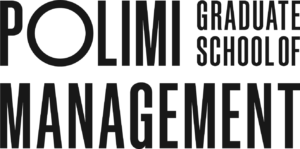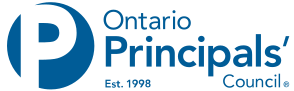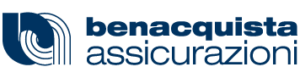Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Filomena Zamboli
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
Guidare sistemi per la persona, direzione pedagogica, collegialità e reti di Ezio Delfino e Filomena Zamboli
Dai decreti delegati alla leadership scolastica. Intervista a Giorgio Chiosso a cura di Ezio Delfino
Società, cultura, educazione: la pedagogia torna a scuola. Dialogo con Andrea Bobbio a cura di Giovanna Battaglia, Paolo M.G. Maino, Elena Viale
Funzionare o esistere. Elogio dell’intranquillità. Intervista a Miguel Benasayag a cura di Nora Terzoli
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Progettazione pedagogica, metacompetenze, talenti, alleanza scuola lavoro. Intervista a Damiano Previtali e Emmanuele Massagli a cura di Mauro Monti
I presidi come leader pedagogici: supportare il successo scolastico, il benessere e lo sviluppo professionale degli insegnanti di Luciana Cardarelli
Leadership pedagogica in azione: come implementare il curricolo aggiornato di lingua. Una risorsa per lo sviluppo professionale in Ontario (Canada) di Cristina Mignatti
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Comunicare al tempo dell’intelligenza artificiale. Racconto di un’esperienza di Maria Cutolo
Direzione pedagogica, interpretazione e modelli: l’esperienza di Daniela Massarotto
Educazione e direzione pedagogica. Nel magistero di Papa Francesco di Paolo M.G. Maino
PARTE IV - CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DI OGGI
Direzione pedagogica, modelli oltralpe leadership educativa tra Francia, Germania e Inghilterra di Ignazio Venzano
The role of pedagogical leadership and professional networks in improving road safety in vocational education di Lavdim Hamiti
Politica per la protezione dei minori e procedure correlate nella rete delle scuole cattoliche dell’Albania (Kkeksh) di Malvina Përgega
Editoriale
La direzione pedagogica non è un concetto nuovo.
Dobbiamo a Cesare Scurati, una delle voci più autorevoli nel contesto della pedagogia italiana contemporanea, il merito di aver delineato un nuovo paradigma per la leadership scolastica.
Il suo contributo si fonda su una visione umanistica della scuola, intesa come luogo privilegiato per la formazione integrale della persona in risposta al rischio di una deriva burocratica dell’autonomia scolastica.
In questa prospettiva, il dirigente scolastico diventa il principale promotore di cultura, innovazione e progettualità educativa.
Tale visione è tanto più attuale oggi, in un contesto segnato da sfide complesse – tecnologiche, culturali, sociali – che richiedono una leadership scolastica capace di coniugare competenza organizzativa, sensibilità pedagogica e visione etica.
Oggi, più che mai, il Dirigente scolastico deve essere in grado formulare una visione educativa coerente, non solo ispirata ai principi della Costituzione – centralità della persona, inclusione, partecipazione –, ma capace di orientare l’azione didattica.
Il dirigente è, quindi, chiamato a essere un catalizzatore di energie, un animatore di comunità professionali, un facilitatore di processi trasformativi.
La sua leadership si manifesta nella capacità di integrare il sapere pedagogico con le competenze gestionali, in una prospettiva sistemica e dialogica.
Non si tratta, però, semplicemente di reinterpretare ridefinire il compito del dirigente scolastico, riscoprendo le radici della sua dimensione pedagogica. Le comunità scolastiche sono chiamate, oggi, ad interpretare un ruolo essenziale nel contesto della società contemporanea.
Dismettendo il compito trasmissivo della conoscenza disciplinare e della cultura in senso ampio, la scuola assume quello fondativo del sapere e quello interpretativo del dialogo educativo con gli studenti.
Una volta parlare di giovani o di giovani generazioni rimandava a concetti univoci e a categorie ben precise.
Oggi non è più così. Senza la pretesa di fare analisi sociologiche, occorre prendere atto che ci troviamo davanti a generazioni di ragazzi diversi, nuovi, per i quali sono state coniate le più svariate definizioni: “non desideranti”, “adultescenti”, “sdraiati”, nell’età del “labirinto”, giovani “mongolfiera”, eccetera. Po- tremmo continuare.
Tali definizioni, non negative ma rivelative di un cambiamento, ci indicano quanto responsabilmente sia necessario implicarsi in un dialogo costante e in tentativi proficui che, dal punto di vista educativo e formativo, ci consentano di far percorrere loro cammini efficaci di crescita.
Per questo abbiamo voluto affrontare il tema della direzione pedagogica a partire da un dialogo a più voci, realizzato nell’annuale Convegno della Associazione DiSAL.
Questo numero intende, infatti, proporre una riflessione approfondita coinvolgendo interlocutori ed esperienze mutuate nel più ampio contesto culturale sociale, anche internazionale.
Se la scuola è anzitutto una comunità educante, un luogo in cui si costruiscono relazioni significative orientate alla crescita integrale della persona, il dirigente pedagogico assume su di sé un ruolo dialogico: è colui che ascolta, media, valorizza le differenze e promuove il confronto costruttivo. Il suo compito è generare coesione senza appiattire la pluralità, favorire l’inclusione senza rinunciare all’eccellenza, sostenere la partecipazione come forma di corresponsabilità educativa.
È colui che costruisce ponti con il territorio, attivando reti interistituzionali e progettualità condivise che rafforzano il legame scuola-comunità in favore degli studenti.
In quest’ottica il numero riprende le radici del concetto di Leadership scolastica, del valore della pedagogia “che torna a scuola”, si avvale di contributi approfonditi sulla leadership pedagogica in sistemi scolastici sia europei che internazionali (Canada, Albania). Fino alla declinazione, in forma di esperienze virtuose, di alcune realtà scolastiche significative.
La scuola contemporanea ha bisogno di un dirigente che non si limita a gestire l’esistente, ma si interroga, problematizza, produce visione. Che agisce sulla base di una cultura pedagogica solida, che legge il contesto in chiave critica e che assume decisioni orientate al bene comune. Insomma, un costruttore di significati, un elaboratore di senso, un promotore di ethos educativo.
Occorre ricominciare, mai stanchi, da una domanda fondamentale rispetto alla complessità in cui siamo immersi e tirati da tutte le parti: non che cosa dobbiamo fare? piuttosto, di cosa siamo fatti?
Come Persone, prima ancora che come Dirigenti scolastici.
Indice
INTRODUZIONE
Editoriale di Filomena Zamboli
PARTE I - IL QUADRO DEL PROBLEMA
Guidare sistemi per la persona, direzione pedagogica, collegialità e reti di Ezio Delfino e Filomena Zamboli
Dai decreti delegati alla leadership scolastica. Intervista a Giorgio Chiosso a cura di Ezio Delfino
Società, cultura, educazione: la pedagogia torna a scuola. Dialogo con Andrea Bobbio a cura di Giovanna Battaglia, Paolo M.G. Maino, Elena Viale
Funzionare o esistere. Elogio dell’intranquillità. Intervista a Miguel Benasayag a cura di Nora Terzoli
PARTE II - TESSERE DEL MOSAICO
Progettazione pedagogica, metacompetenze, talenti, alleanza scuola lavoro. Intervista a Damiano Previtali e Emmanuele Massagli a cura di Mauro Monti
I presidi come leader pedagogici: supportare il successo scolastico, il benessere e lo sviluppo professionale degli insegnanti di Luciana Cardarelli
Leadership pedagogica in azione: come implementare il curricolo aggiornato di lingua. Una risorsa per lo sviluppo professionale in Ontario (Canada) di Cristina Mignatti
PARTE III - ESPERIENZE A CONFRONTO
Comunicare al tempo dell’intelligenza artificiale. Racconto di un’esperienza di Maria Cutolo
Direzione pedagogica, interpretazione e modelli: l’esperienza di Daniela Massarotto
Educazione e direzione pedagogica. Nel magistero di Papa Francesco di Paolo M.G. Maino
PARTE IV - CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DI OGGI
Direzione pedagogica, modelli oltralpe leadership educativa tra Francia, Germania e Inghilterra di Ignazio Venzano
The role of pedagogical leadership and professional networks in improving road safety in vocational education di Lavdim Hamiti
Politica per la protezione dei minori e procedure correlate nella rete delle scuole cattoliche dell’Albania (Kkeksh) di Malvina Përgega
Editoriale
La direzione pedagogica non è un concetto nuovo.
Dobbiamo a Cesare Scurati, una delle voci più autorevoli nel contesto della pedagogia italiana contemporanea, il merito di aver delineato un nuovo paradigma per la leadership scolastica.
Il suo contributo si fonda su una visione umanistica della scuola, intesa come luogo privilegiato per la formazione integrale della persona in risposta al rischio di una deriva burocratica dell’autonomia scolastica.
In questa prospettiva, il dirigente scolastico diventa il principale promotore di cultura, innovazione e progettualità educativa.
Tale visione è tanto più attuale oggi, in un contesto segnato da sfide complesse – tecnologiche, culturali, sociali – che richiedono una leadership scolastica capace di coniugare competenza organizzativa, sensibilità pedagogica e visione etica.
Oggi, più che mai, il Dirigente scolastico deve essere in grado formulare una visione educativa coerente, non solo ispirata ai principi della Costituzione – centralità della persona, inclusione, partecipazione –, ma capace di orientare l’azione didattica.
Il dirigente è, quindi, chiamato a essere un catalizzatore di energie, un animatore di comunità professionali, un facilitatore di processi trasformativi.
La sua leadership si manifesta nella capacità di integrare il sapere pedagogico con le competenze gestionali, in una prospettiva sistemica e dialogica.
Non si tratta, però, semplicemente di reinterpretare ridefinire il compito del dirigente scolastico, riscoprendo le radici della sua dimensione pedagogica. Le comunità scolastiche sono chiamate, oggi, ad interpretare un ruolo essenziale nel contesto della società contemporanea.
Dismettendo il compito trasmissivo della conoscenza disciplinare e della cultura in senso ampio, la scuola assume quello fondativo del sapere e quello interpretativo del dialogo educativo con gli studenti.
Una volta parlare di giovani o di giovani generazioni rimandava a concetti univoci e a categorie ben precise.
Oggi non è più così. Senza la pretesa di fare analisi sociologiche, occorre prendere atto che ci troviamo davanti a generazioni di ragazzi diversi, nuovi, per i quali sono state coniate le più svariate definizioni: “non desideranti”, “adultescenti”, “sdraiati”, nell’età del “labirinto”, giovani “mongolfiera”, eccetera. Po- tremmo continuare.
Tali definizioni, non negative ma rivelative di un cambiamento, ci indicano quanto responsabilmente sia necessario implicarsi in un dialogo costante e in tentativi proficui che, dal punto di vista educativo e formativo, ci consentano di far percorrere loro cammini efficaci di crescita.
Per questo abbiamo voluto affrontare il tema della direzione pedagogica a partire da un dialogo a più voci, realizzato nell’annuale Convegno della Associazione DiSAL.
Questo numero intende, infatti, proporre una riflessione approfondita coinvolgendo interlocutori ed esperienze mutuate nel più ampio contesto culturale sociale, anche internazionale.
Se la scuola è anzitutto una comunità educante, un luogo in cui si costruiscono relazioni significative orientate alla crescita integrale della persona, il dirigente pedagogico assume su di sé un ruolo dialogico: è colui che ascolta, media, valorizza le differenze e promuove il confronto costruttivo. Il suo compito è generare coesione senza appiattire la pluralità, favorire l’inclusione senza rinunciare all’eccellenza, sostenere la partecipazione come forma di corresponsabilità educativa.
È colui che costruisce ponti con il territorio, attivando reti interistituzionali e progettualità condivise che rafforzano il legame scuola-comunità in favore degli studenti.
In quest’ottica il numero riprende le radici del concetto di Leadership scolastica, del valore della pedagogia “che torna a scuola”, si avvale di contributi approfonditi sulla leadership pedagogica in sistemi scolastici sia europei che internazionali (Canada, Albania). Fino alla declinazione, in forma di esperienze virtuose, di alcune realtà scolastiche significative.
La scuola contemporanea ha bisogno di un dirigente che non si limita a gestire l’esistente, ma si interroga, problematizza, produce visione. Che agisce sulla base di una cultura pedagogica solida, che legge il contesto in chiave critica e che assume decisioni orientate al bene comune. Insomma, un costruttore di significati, un elaboratore di senso, un promotore di ethos educativo.
Occorre ricominciare, mai stanchi, da una domanda fondamentale rispetto alla complessità in cui siamo immersi e tirati da tutte le parti: non che cosa dobbiamo fare? piuttosto, di cosa siamo fatti?
Come Persone, prima ancora che come Dirigenti scolastici.