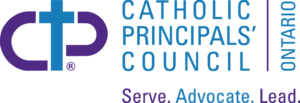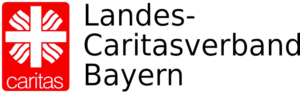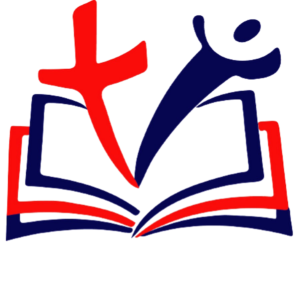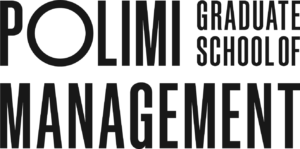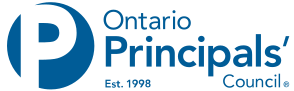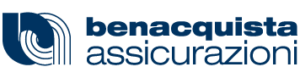Fonte: Il sussidiario.net
Articolo di Maria grazia Fornaroli
L’investimento e la morte della pensionata di Milano a opera di 4 minori rom apre molte riflessioni. Una di queste riguarda la scuola
Per chi abbia radici meneghine, ma non solo, la vicenda della pensionata uccisa da 4 ragazzini Rom (poco più che bambini) è un evento drammatico ma insieme paradigmatico. Negli stessi giorni in cui le pagine di cronaca sono dense dei testi degli interrogatori relativi ai protagonisti della nuova Milano, quella dei grattacieli e dei progetti miliardari, scopriamo che, nella periferia sud, un campo nomadi accoglie decine di donne e bambini (gli uomini sono tutti in galera).
Nomadi che vivono inevitabilmente di espedienti, nomadi bambini che evadono quotidianamente l’obbligo scolastico e che trascorrono l’infanzia tra furti e piccoli reati. Questi ragazzini, in un giorno torrido di agosto, sono stati capaci di rubare un’auto lasciata incustodita da turisti poco previdenti, di impossessarsi dei bagagli, tra i quali si trovava una copia delle chiavi dell’accensione dell’auto, accendere il motore e organizzare una scorribanda.
Ma a 14 anni non si sa guidare e quindi, a poca distanza dal luogo del furto, hanno perso il controllo dell’auto, hanno superato il cordolo di un giardino e hanno investito una donna, una settantenne che era appena uscita da un luogo di accoglienza che frequentava, annesso alla parrocchia.
La signora, deceduta quasi immediatamente, vedova, era arrivata dalla Puglia a Milano quarant’anni fa, si era inserita nella Milano produttiva di allora, lavorando al Cotonificio “Cederna”, che in quegli anni rappresentava ancora una grande opportunità di integrazione produttiva anche per le donne.
Nel mistero di questa morte si scontrano anche due modelli sociali divergenti. Senza prendere la via della “laudatio temporis acti”, non si può che esprimere nostalgia di una milanesità, quella del dopoguerra, molto più capace di integrare rispetto al drammatico modello attuale in cui le due città, quella delle archistar e dei dehors e quella delle periferie, non si parlano più.
Il luogo dove è avvenuta la tragedia, Gratosoglio, pur con etimologia incerta, era uno dei “corpi santi”, luogo certamente periferico, ma ricco d’acqua, sede di importanti comunità monastiche attestate fin dal XII secolo, quella di san Barnaba vallombrosiana e quella delle Benedettine, modelli di carità ma anche di operoso impegno nella coltivazione dei campi, modello di una socialità capace di reale integrazione.
Di questa socialità capace di accoglienza costruttiva, Milano ha fatto grande esperienza nel dopoguerra del secolo scorso, in cui ancora la città, sollevatasi dalle macerie reali e metaforiche del conflitto, ha rappresentato per molti un modello di società in grado di accogliere, integrare, consentire a moltissimi di trovare case a prezzi sostenibili, scuole e sanità adeguate.
Si ricordi il modello della scuola pomeridiana in cui i servizi comunali di prescuola, refezione, doposcuola e giochi serali consentivano un’efficace integrazione con l’offerta statale della scuola mattutina oppure, sempre nella scuola, la presenza di assistenti sanitari stabili, capaci di intercettare bisogni e di integrarsi con i servizi sociali prima che l’emergenza esplodesse.
Gli anni 60 e 70 sono stati per la milanesità un luminoso esempio di città accogliente e misurata. Il dramma dell’emarginazione esisteva, il grande Giovanni Testori ne ha scritto pagine memorabili, ma si trattava di esperienze contenute. Figli di operai che affrontarono studi in licei prestigiosi e acquisirono titoli accademici ce ne furono. Imprenditori intraprendenti ma misurati, anche. Costruttori capaci di creare quartieri dignitosi a costi accessibili pure.
Ora prevale una “diabolica” (diavolo è colui che divide) scissione, una dicotomia drammatica tra la città dei grattacieli e i campi nomadi.
In un’intervista di ieri un magistrato appena andato in pensione urla il suo sgomento per quanto accaduto e chiede che l’istituzione scolastica si faccia carico dell’integrazione di questi piccoli Rom, divenuti omicidi.
No, gentile dottore, la scuola da sola non basta, occorre che tutta la società milanese (ma non solo) si impegni per tentare di ricostruire quella capacità di tessere legami, in una logica di sussidiarietà, di cui le comunità del passato sono state capaci. Tessitura, come l’opificio in cui la vittima di oggi, tanti anni fa emigrata da un Sud in difficoltà, aveva trovato un luogo capace di offrire dignità a lei e alla sua famiglia.
Tessitura, non delega, un modello di società capace di costruire legami, quella a cui il grande Ambrogio aveva guardato in anni ben più drammatici dei nostri, e dopo di lui, secoli dopo, ma tanto più bui, il cardinale Borromeo. Di esempi Milano ne ha, basterebbe cercare, “mutatis mutandis” , trovarne ispirazione.