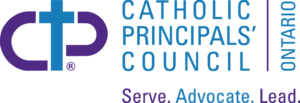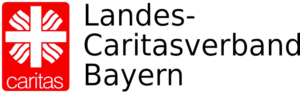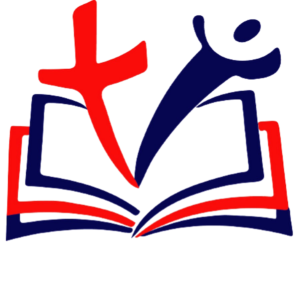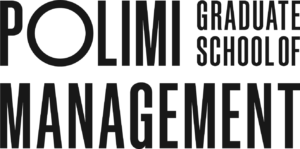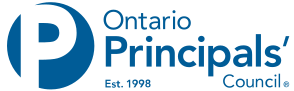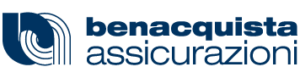Articolo di Giuseppe Mariani
1) LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Lo scorso 25 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.”
Il provvedimento interviene sul D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, il decreto che, in attuazione dell’art. 21 della L. n. 59/1997, aveva introdotto lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (nel seguito: Statuto) nell’ambito dei provvedimenti istitutivi dell’autonomia scolastica (era Ministro Luigi Berlinguer). Successivamente, lo Statuto fu revisionato nel 2007 a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 235, voluto dal Ministro Giuseppe Fioroni a fronte di episodi che avevano destato allarme nella pubblica opinione (quali atti di violenza su disabili o gravi danneggiamenti a strutture scolastiche a seguito di atti di vandalismo).
Con la riscrittura dell’art. 4 (Disciplina) furono reintrodotte le sanzioni più gravi, quali l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni nonché quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo: sanzioni rimesse alla competenza del consiglio di istituto su proposta del consiglio di classe.
Dalla L. n. 150/2014 al D.P.R. n. 134/2025
Anche oggi, come ieri, le modifiche introdotte con D.P.R. n. 134 rispondono alla necessità di affrontare i crescenti fenomeni di violenza fisica e psicologica, bullismo e aggressività che coinvolgono alunni e personale scolastico. La matrice del nuovo provvedimento si colloca nella L. n. 150/2024, il cui art. 1, c. 4, ha delegato il Governo a provvedere «alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti“ tramite “uno o più regolamenti».
I fini dichiarati sono quelli di:
- ripristinare la cultura del rispetto
- affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado
- rimettere al centro il principio della responsabilità
- restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.
Nel successivo c. 5 sono dettagliati gli indirizzi da assumere.
Quali i principali cambiamenti introdotti con il D.P.R. n. 134?
1) Viene introdotta la distinzione fra «allontanamento dalle lezioni» e «allontanamento dalla comunità scolastica»: il primo, fino a 15 giorni, è di competenza del consiglio di classe, il secondo, superiore ai 15 giorni, rimane di competenza del consiglio d’istituto.
2) A sua volta, la sanzione dell’«allontanamento dalle lezioni» può essere comminata dal consiglio di classe su due step: fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni. Nel primo caso, le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di «approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare»; nel secondo caso, tali attività si svolgono presso «le strutture ospitanti […] con le quali l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, stipula convenzioni».
Viene, altresì, implementata l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità (art. 5-bis, c. 1-ter), nel quale viene ora introdotto l’impegno esplicito alla collaborazione per favorire l’emersione di episodi di bullismo, cyberbullismo, abuso di alcool e sostanze, e altre forme di dipendenza (anche dai messaggi della rete internet).
Cosa si intende con “strutture ospitanti”?
Si tratta di enti, associazioni e enti del Terzo settore che aderiscono ad apposito avviso pubblico predisposto dall’USR sulla base di requisiti e di criteri definiti dal MIM. Spetta all’USR, dopo averne verificato i requisiti, fornire alle scuole gli elenchi degli enti idonei.
Le scuole, a loro volta, evidenziano nel PTOF quali siano le attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso tali strutture da parte dei propri studenti “allontanati” nonché le relative modalità di raccordo e di coordinamento: a tal fine, le scuole «individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell’ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il MOF» (art. 5, c. 8-ter).
Il Regolamento precisa ulteriormente che:
- durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l’obbligo di vigilanza sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze;
- le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale vanno computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti;
- il mancato o parziale svolgimento di tali attività viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento.
Cosa succede in assenza di “strutture ospitanti”?
Lo Statuto (nuovo comma 8-quater dell’art. 4) prevede la possibilità dell’assenza di “strutture ospitanti” idonee e/o disponibili: in tal caso, «le attività di cittadinanza attiva e solidale (…) sono svolte a favore della comunità scolastica». Ne deriva che gli studenti sanzionati disciplinarmente con l’allontanamento(a vario titolo) hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola per lo svolgimento di “attività di cittadinanza” appositamente organizzate.
Cosa succede quando l’allontanamento è superiore a quindici giorni?
L’allontanamento qualificato come “allontanamento dalla comunità scolastica” ha una durata superiore ai 15 giorni e include, altresì, le sanzioni gravissime dell’esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all’esame di Stato.
Il provvedimento è disposto dal consiglio d’istituto, su proposta del consiglio di classe, nei casi specificamente previsti al nuovo comma 9 dell’art. 4 dello Statuto:
- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
Anche in tali casi la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito «un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica», coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l’autorità giudiziaria.
Il senso delle sanzioni disciplinari nel quadro della comunità civile e sociale
Le modifiche regolamentari apportate allo Statuto dal D.P.R. n. 134 sottolineano l’appartenenza dell’istituzione scolastica al più ampio contesto della comunità civile e sociale del territorio, istituendo pratiche di corresponsabilità nell’educazione dei giovani.
Perché l’individuazione delle “strutture ospitanti” non si riduca aun macchinoso esercizio procedurale, occorre ravvisarne e valorizzarne le funzionalità educative. Le realtà organizzate presenti nei contesti dove si svolge la vita delle giovani generazioni offrono possibilità incredibili di esperienze che favoriscono l’acquisizione di competenze relazionali e civili, utilizzabili come palestre per l’apprendimento (o riapprendimento) delle regole di convivenza e di rispetto di ogni identità altrui: basti solo pensare al mondo del volontariato, proiettato sulla cura dei bisogni e dei diritti dei più deboli e, perciò, orientato al superamento delle pulsioni egotiche che alimentano involuzioni nella crescita, quali il bullismo, il ricorso all’alcool e a sostanze stupefacenti, l’uso predatorio della sessualità.
La gestione della fase dell’adeguamento
La tempistica dell’adeguamento allo Statuto rinnovato è stringente, sia al livello del Ministero sia a quello delle singole istituzioni scolastiche.
Con il D.P.R. n. 134 il Ministero è impegnato:
- al livello centrale: a definire “i requisiti e i criteri” che consentano a enti, associazioni e enti del Terzo settore di manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente sanzionato in attività di cittadinanza attiva e solidale a seguito di partecipazione all’avviso pubblicato dall’USR;
- al livello territoriale dell’USR: a pubblicare l’avviso, a verificare l’aderenza ai requisiti ministeriali delle disponibilità pervenute, a pubblicare gli elenchi degli enti idonei.
Non occorre il dono della profezia per prevedere tempi lunghi: tempi, d’altronde, motivati dalla necessità di fornire agli studenti e alle scuole che si appoggeranno alle reti esterne le migliore garanzie di competenza educativa nell’esercizio delle responsabilità di cui all’art. 2048 del cod. civ.
Nel frattempo, tuttavia, le modifiche allo Statuto diventano esecutive il 10 ottobre prossimo. Donde, per le scuole, l’impegno:
- alla revisione, entro 30 giorni, dei propri Regolamenti di disciplina per adeguarli alla nuova gestione dell’istituto dell’«allontanamento” dalle lezioni / dalla comunità scolastica» e, in generale, alle innovazioni apportate allo Statuto;
- a individuare nel PTOF le attività di cittadinanza attiva e solidale nelle quali inserire gli studenti destinatari di provvedimenti disciplinari di allontanamento;
- a preventivare, nelle more dell’adeguamento (ossia: in attesa della pubblicazione degli elenchi regionali), modalità e contenuti di tali attività, poste totalmente in capo alle scuole.
2) COME SI CONFIGURA OGGI IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLO STUDENTE
Le modifiche dello Statuto, introdotte con il D.P.R. n. 134, incidono altresì sulla conduzione del procedimento disciplinare.
Si tenga conto, preliminarmente, che il procedimento disciplinare a carico dello studente altro non è che uno specifico procedimento amministrativo, regolato dall’applicazione dei principi, delle garanzie e delle procedure previsti dal procedimento amministrativo in generale, di cui alla legge n. 241/1990. Inoltre, nella giurisprudenza amministrativa, è costante il rinvio (per analogia) alla regolamentazione del procedimento disciplinare vigente nel pubblico impiego, come codificato nelle Norme generali del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001, art. 55-bis) e, per quanto di dettaglio, nei CCNL di comparto.
L’aggiornamento del Regolamento d’istituto
Sappiamo che l’iter di approvazione del Regolamento d’istituto prevede, obbligatoriamente, i due passaggi della proposta del collegio dei docenti e della delibera di approvazione del consiglio d’istituto: la procedura è richiesta sia per l’iniziale formulazione sia per ogni successiva modifica.
Nello specifico, l’art. 6 (c. 1) dello Statuto delle studentesse e degli studenti:
- al c. 1 prescrive che «I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media»;
- al c. 1-bis (novella introdotta dal D.P.R. n. 134) prescrive che «Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all’articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies»: si tenga conto che il D.P.R. n. 134 entra in vigore il 10 ottobre 2025.
Con il Regolamento di disciplina dell’istituto vanno individuati:
- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri indicati nell’art. 3 del D.P.R. n. 249/1998, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola;
- le sanzioni relative;
- gli organi competenti ad irrogarle;
- il procedimento;
- la composizione e le modalità di funzionamento dell’organo interno di garanzia.
Alle scuole viene richiesto, quindi, lo sforzo di “tipizzazione” di quei comportamenti cui ricollegare le sanzioni: non basta un rinvio generico allo Statuto governativo che, di per sé, non contiene fattispecie tipizzate se non nei casi gravissimi (v. sopra).
Le quattro fasi del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare, al pari di ogni procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:
1. Fase dell’iniziativa
Si apre a cura del dirigente scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di istituto come passibili di sanzioni disciplinari. Questa fase viene attivata con la comunicazione scritta dell’avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenne.
Tale comunicazione si sostanzia della contestazione degli addebiti risultanti al momento, indicandone le circostanze di tempo, luogo e azione. Allo studente incolpato vanno indicate le modalità dell’audizione a difesa in sede di consiglio di classe o, preliminarmente, nelle sedi ritenute opportune.
L’atto si conclude individuando il responsabile dell’istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso: può essere il coordinatore del consiglio di classe oppure il docente presente alla commissione dell’illecito. Se non è indicato, è il dirigente scolastico stesso.
2. Fase istruttoria
Il dirigente scolastico / il responsabile dell’istruttoria raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell’evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili (di cui redige verbale) e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.
A questo punto, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe completo di tutte le sue componenti: la convocazione va notificata allo studente indiziato di responsabilità e, se minorenne, ai relativi esercenti la potestà genitoriale. Il verbale della seduta documenta le posizioni espresse in fase di dibattimento; ad esso va allegata la documentazione raccolta in fase di istruttoria. Si tenga presente che il consiglio di classe può irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni (nei due step sopra illustrati).
Ai sensi dello Statuto (art. 4), le sanzioni:
- sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- influiscono sul voto di comportamento e non sulla valutazione degli apprendimenti;
- tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;
- riconoscono la libera espressione di opinioni purché correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.
Deliberando la sanzione, il consiglio di classe propone altresì, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni.
Per la legittimità del provvedimento assunto, è essenziale fornirne adeguata motivazione, tramite la quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria (L. n. 241/1990, art. 3) al fine di evitare vizi (quali l’eccesso di potere o la violazione di legge) che possono comportarne l’annullamento in sede di ricorso.
Qualora il consiglio di classe, sulla base del Regolamento d’istituto e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del consiglio d’istituto.
3. Fase decisoria
In base alle risultanze del verbale dell’organo collegiale competente, il dirigente scolastico formalizza l’atto conclusivo, che può essere di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento – va sempre ricordato – devecontenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione o alla sua archiviazione, esplicitando l’iter logico-giuridico dell’intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto.
Il provvedimento indica, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni: struttura ospitante, luogo, tempi e condizioni di frequenza, contenuti e obiettivi, docente referente interno all’istituzione scolastica.
Si conclude indicando il termine (quindici giorni dalla comunicazione) e l’organo (Organo di garanzia interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
4. Fase integrativa dell’efficacia.
Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con lamassima sollecitudine, all’interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, può essere attuataimmediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione.
Le impugnazioni
Lo Statuto (art. 5) offre allo studente (agli esercenti la responsabilità genitoriale, se minorenne) la possibilità di unduplice livello di ricorso all’interno dell’amministrazione scolastica:
- di primo grado: all’Organo interno di garanzia;
- di secondo grado: al direttore dell’USR.
L’Organo interno di garanzia
Con il ricorso all’Organo interno di garanzia possono essere sollevate eccezioni:
- sul merito del provvedimento adottato;
- sulla legittimità dello stesso, alla luce del Regolamento d’istituto, dei principi generali del procedimento amministrativo e delle regole di impugnazione dei provvedimenti conclusivi.
Tale organo è attivato e regolato dal consiglio d’istituto, tenendo conto che lo Statuto ne indica i requisiti minimi di composizione:
- un docente designato dal consiglio di istituto;
- nella scuola secondaria di secondo grado: un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori;
- (ovvero) nella scuola secondaria di primo grado: due rappresentanti eletti dai genitori;
- il dirigente scolastico che lo presiede in qualità di responsabile legale dell’istituto.
Soddisfatti tali requisiti, il Regolamento d’istituto delibera:
- la composizione dell’organo quanto a numero e qualifica dei componenti, prevedendo altresì supplenti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’Organo un membro dell’organo collegale che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore);
- la durata in carica, le procedure di elezione e di surroga dei membri;
- le modalità di funzionamento: convocazione e validità delle sedute e delle deliberazioni;
- le modalità di assunzione delle delibere: a maggioranza dei presenti, a maggioranza assoluta, computo degli astenuti, prevalenza, in caso di parità, del voto del presidente
L’organo interno di garanzia decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, che va presentato entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
Reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
In materia di violazioni dello Statuto, contenute anche nei singoli Regolamenti d’istituto, è possibile indirizzare, da parte di chiunque abbia interesse, un reclamo al direttore dell’USR, che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell’Organo regionale di garanzia.
Tale Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto:
- per la scuola secondaria di secondo grado: da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale; è presieduto dal direttore dell’USR o da un suo delegato.
- per la scuola secondaria di primo grado: in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Data la natura dell’istanza, la decisione assume il carattere di valutazione di legittimità rispetto allo Statuto, anche con riferimento alla conformità ad esso del Regolamento d’istituto.
L’Organo ha il compito di verificare «la corretta applicazionedella normativa e dei regolamenti” e svolge la propria attività istruttoria “esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione» (art. 5, c. 4).
Il direttore dell’USR decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, previo parere vincolante dell’Organo di garanzia regionale.
Circa i termini per l’impugnazione, nel silenzio dello Statuto, si ritiene che siano gli stessi per il ricorso all’organo interno di garanzia (15 giorni).