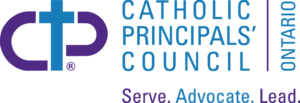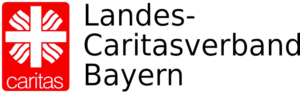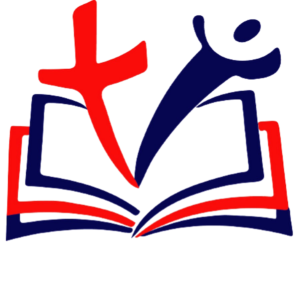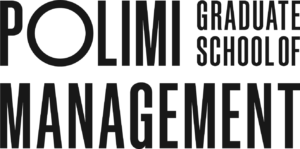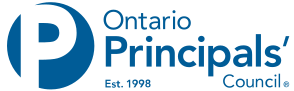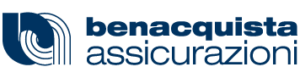Fonte: Orizzonte Scuola
Articolo di Lucio Scribani
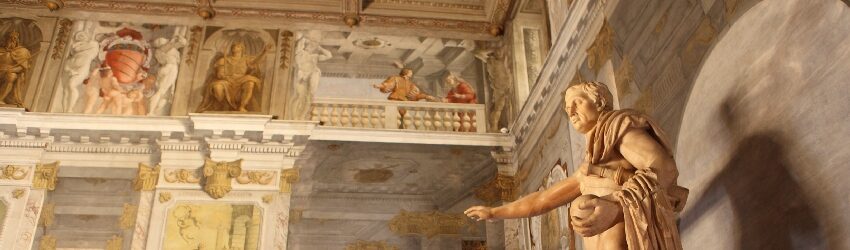
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, evidenziando gravi carenze nell’analisi di impatto della regolamentazione presentata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La decisione della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, resa nel parere numero 1017/2025 del 17 settembre, rappresenta uno stop significativo nel processo di approvazione delle Nuove Indicazioni Nazionali.
Criticità dell’analisi di impatto regolamentare
La documentazione predisposta dal Ministero, secondo quanto si legge nel dispositivo, presenta lacune strutturali che compromettono la valutazione della proposta normativa. L’analisi di impatto della regolamentazione risulta inadeguata sotto molteplici profili: mancano evidenze misurabili delle carenze delle attuali Indicazioni, non emergono le ragioni specifiche delle modifiche introdotte e risultano assenti indicatori quantitativi per misurare l’efficacia degli interventi proposti. La relazione illustrativa si limita a evocare genericamente i “cambiamenti epocali” dell’ultimo decennio senza fornire una puntuale descrizione delle inadeguatezze normative riscontrate.
Particolare attenzione meritano alcuni concetti utilizzati nel testo, come la “dispersione digitale” e la “rigenerazione del paradigma formativo“, che necessitano di definizioni univoche e della portata dimensionale del fenomeno. Il Consiglio di Stato rileva inoltre l’incompletezza dell’analisi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, nonostante il testo delle Indicazioni contenga numerosi riferimenti ad atti comunitari.
Problematiche organizzative e finanziarie
Significative perplessità emergono riguardo l’insegnamento del latino per l’educazione linguistica, introdotto come disciplina facoltativa nelle scuole secondarie di primo grado. Le criticità riguardano sia l’aspetto dell’equità educativa, con il rischio di aumentare il divario tra studenti, sia questioni organizzative concrete: i docenti di lettere potrebbero non possedere i requisiti necessari per l’insegnamento del latino, mentre un docente della classe di concorso specifica potrebbe teoricamente insegnare in diciotto classi diverse. La neutralità finanziaria dell’intervento, pur essendo sancita da una clausola di invarianza, solleva dubbi circa l’effettiva disponibilità di mezzi e risorse per il conseguimento degli obiettivi delineati. La relazione tecnica non contiene una formale verifica positiva da parte della Ragioneria generale dello Stato, limitandosi alla bollinatura del documento.
Richieste di integrazione documentale
Il Consiglio di Stato richiede una rinnovazione complessiva dell’analisi preventiva di impatto, con eventuale riscrittura di parti del testo delle Indicazioni. Necessaria risulta l’integrazione dell’analisi di compatibilità con gli atti dell’Unione europea e una maggiore considerazione delle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. La documentazione presenta errori formali e refusi che richiedono correzione, dalla mancata menzione del controllo preventivo della Corte dei Conti nel preambolo alle incongruenze terminologiche nelle disposizioni transitorie. La sospensione del parere comporta il rinvio dell’iter di approvazione fino al completamento degli adempimenti richiesti dalla Sezione Consultiva.
Il parere
Testo
Le modifiche effettuate a luglio dal Ministero
Come già avevamo avuto modo di scrivere, il Ministero, nel mese di luglio, rispetto alla prima bozza, aveva effettuato alcune modifiche. Ad esempio, la premessa culturale è stata ampliata con una riflessione più articolata sul ruolo della comunità educante e sull’integrazione tra scuola, famiglia e territorio. Viene rafforzato il concetto di “comunità educante” e si sottolinea il coinvolgimento del terzo settore, non presente nel primo testo. Nella seconda versione, si trova un’esplicita valorizzazione della figura del docente come “Magister”, con un accento sull’autorevolezza ritrovata e sulla funzione di valorizzazione dei talenti. La sottolineatura non era presente nel primo testo, dove la figura del docente era trattata in modo più tradizionale.
Nel testo definitivo, come aveva già scritto, si introducono due nuovi paragrafi: uno dedicato all’internazionalizzazione come dimensione trasversale del curricolo (con riferimenti a gemellaggi, CLIL, uso delle tecnologie per l’apprendimento collaborativo), e uno sull’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come parte integrante dell’educazione civica e delle discipline STEM. Nella versione finale, la sezione sugli obiettivi generali del processo formativo è stata riformulata per chiarire che la scelta degli obiettivi educativi generali deve essere annualmente adattata dal team docente alla realtà della classe. Si specifica inoltre che tali obiettivi guidano la progettazione didattica, la formulazione dei giudizi e la certificazione delle competenze.
Nella seconda versione, la parte sulla valutazione è aggiornata con riferimenti all’European Quality Framework (EQF) e all’analisi comparativa con i documenti europei. Si sottolinea la necessità di distinguere tra conoscenze di superficie e conoscenze profonde, e si introduce il concetto di “curriculum makers” per i docenti. Inoltre, si rafforza il ruolo della documentazione e della corresponsabilità valutativa, con un richiamo esplicito alla governance e al middle-management. Rispetto alla versione precedente, si trova una riflessione più approfondita sull’integrazione delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella didattica, con l’indicazione di una “strategia abilitante” sull’IA, che deve essere integrata criticamente e non solo come assistenza tecnica. Si parla di ecosistema umano di istruzione digitale, tema assente nel primo testo.