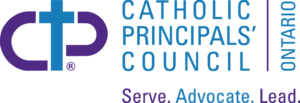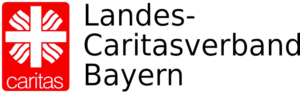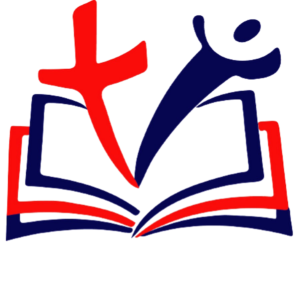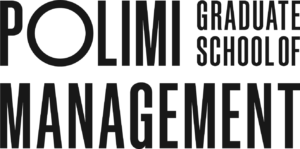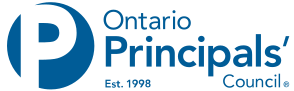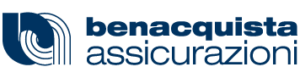Fonte: IlSussidiario.net
Articolo di Cesare Maria Cornaggia

Di fronte al malessere giovanile gli adulti sono spesso spaesati e pensano di essere necessariamente di fronte a una patologia
Analisi, analisi, analisi… Non solo delle geopolitica mondiale, ma anche del malessere giovanile per parlare di incomunicabilità, assenza di prospettive… Si potrebbe citare Gaber che diceva: “È un gran vuoto / che vi circonda e che vi blocca”, ma anche Bennato con il suo “Dotti, medici e sapienti” che irrideva al nulla tronfio e presuntuoso chi fa queste analisi e invitava il ragazzo a scappare. È l’unico approccio? Si può invece cercare di “aprire la possibilità alla persona di venire in contatto con le sue parti profonde, di riconoscerle e aprirle all’impatto con la realtà come la totalità che sta dinanzi a noi”. A noi la scelta.
In questo tempo si parla tanto del cosiddetto “malessere giovanile” e del disorientamento di molti adulti dinanzi a questo e agli eventi troppo spesso di cronaca dei quali tutti siamo spettatori. D’altra parte, oggi ci troviamo di fronte a qualcosa di così quantitativamente e qualitativamente diverso rispetto al passato che appare evidente come la natura di ciò a cui siamo dinnanzi non sia per nulla nota e che i parametri psicologici o educativi che ci hanno accompagnato negli anni passati non siano sono più d’aiuto.
Dal punto di vista psicologico noi fatichiamo a leggere questo disagio, in quanto il “sintomo”, che abbiamo sempre considerato la porta di accesso alla sfera profonda della persona, oggi ci appare molto più complesso da decifrare e in generale ci risulta più come una rottura,piuttosto che come una domanda.
Proprio per questo credo che oggi si debba affermare che la centralità della questione non può essere slegata da quella del linguaggio e della relazione, perché siamo davanti a una domanda che non riesce oppure fatica a tradursi linguisticamente.
Questo, a mio parere, accade sostanzialmente per tre motivi: il primo è che le emozioni non sono riconosciute, né da chi le vorrebbe esprimere, né da chi le vorrebbe ascoltare; il secondo, molto legato al primo, è che il corpo, come ci ha insegnato la terminologia fenomenologica, resta Koeper (un corpo oggetto) e non si mette in gioco come Leib (un corpo vissuto, relazionale, dialogante); infine, il terzo motivo è che siamo dinanzi a una caduta del simbolico, cioè di quella dimensione del linguaggio che rinvia a un ordine di significati condivisi e che va oltre al segno.
Pensiamo alla lingua degli attuali rapper, che potrebbero essere ben definiti da quello che Giorgio Gaber nel suo geniale e profetico “Il Grido” affermava nel 1998: “È un gran vuoto / che vi circonda e che vi blocca / come se fosse un grido / in cerca di una bocca … È una rabbia / che vi stravolge e che vi blocca”.
La bocca è infatti quel linguaggio che non comunica il grido, perché il grido e il linguaggio sono possibili soltanto dentro alla relazione, all’accoglimento, al giudizio senza biasimo dell’altro. I rapper invece ci dicono che loro, pur avendo tutto, non hanno nulla, perché manca l’essenziale e il desiderio resta isolato.
D’altra parte, sono i giovani stessi che utilizzano un linguaggio complicato, criptico, perché hanno loro stessi bisogno di restare non capiti dentro alla barriera dell’incomunicabilità che avvertono dove l’adulto appunto resta lontano. I ragazzi hanno interiorizzato, inoltre, come nominare le emozioni significhi perturbare gli adulti stessi e scelgono il silenzio o la rabbia come codici alternativi (gli unici forse a loro disponibili). Ma se la rabbia parla per loro, non parla di loro.
Di fronte a tutto questo, cosa possiamo chiederci noi apparenti adulti? Nel ricordarci che l’inquietudine del nostro umano e la ricerca di senso sono sempre le stesse per qualsiasi generazione, possiamo richiamarci a due punti sostanziali: che l’io è irriducibile, cioè che non esiste condizione che possa ridurre l’uomo ai suoi antecedenti biologici o psicologici (come li chiamava Giussani) e che ciò che urge coltivare è l’autocoscienza, cioè quella percezione chiara e amorosa di sé che ci permette di abbracciare noi stessi nella consapevolezza del nostro destino, e che, come secondo punto sostanziale, la persona trova se stessa soltanto in un incontro vivo, in una presenza che fa scoppiare il suo cuore.
Pertanto, dinanzi a questo disagio, possiamo affermare che non siamo dinanzi a qualcosa di “patologico”, a una “malattia”, ma al bisogno ontologico di essere amati e riconosciuti per come siamo, in tutte le nostre parti, senza che ricada su di noi il biasimo o l’assenza di prospettive. Solo così, come diceva ancora Giussani, evitiamo la trascuratezza dell’io (che tante volte traspare proprio dietro al citato “malessere” di cui ci lamentiamo) e possiamo sperimentare nel mondo il muoversi, non “per essere amati”, ma “perché amati”.
Se siamo però dinanzi a qualcosa di ontologico, la nostra attenzione, per noi che ci occupiamo di cura o di educazione, non deve andare sulla “malattia”, ma sull’aprire la possibilità alla persona di venire in contatto con le sue parti profonde, di riconoscerle e aprirle all’impatto con la realtà come la totalità che sta dinanzi a noi.
E di fronte a queste provocazioni, mi vengono in mente alcune parole chiave dalle quali partire: la curiosità per l’altro, il riconoscimento (“vedo tutto te, non la tua malattia”), l’irriducibilità dell’io (non vi è condizione in cui esso non sia evocabile e il limite è il luogo del nostro possibile incontro), lo stare davanti al dolore (che è una risorsa), il giudizio senza biasimo, la vicinanza (l’esser-ci, perché tutti noi ci definiamo nella relazione).
D’altra parte, tutto questo non si distingue in fondo dal metodo educativo che ci indicava Giussani, il quale deve partire dall’esperienza che valorizza le domande e i bisogni dell’io, quindi dall’educare a guardare tutta la realtà senza censure, sino al proporre una compagnia umana significativa, per richiamare la persona alla sua seria verifica personale, cioè al valutare se quanto incontra corrisponde o no alle proprie esigenze del cuore.
La provocazione del giovane e la sua richiesta che passa attraverso il linguaggio criptico che ci propone ci provoca a mettere in atto tutto questo più che a individuare patologie nuove.