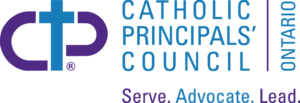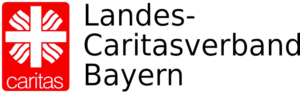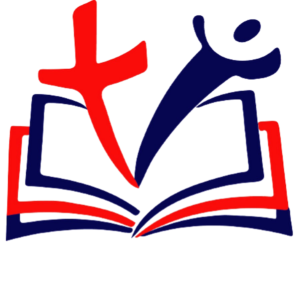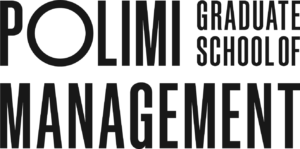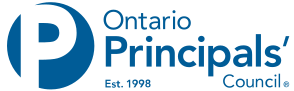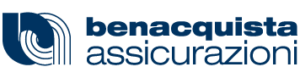Fonte: Sussidiario.net
Articolo di Giorgio Chiosso

Tre snodi storici hanno pregiudicato, anche se si vuole ignorarlo, il tema della scuola paritaria. La battaglia degli spiccioli non ha futuro
Il binomio libertà di insegnamento e scuole cattoliche ha a lungo accompagnato la storia del movimento cattolico italiano tra Otto e Novecento, oscillando tra resistenza allo statalismo monopolistico e orgogliosa rivendicazione di una tradizione che, intrecciandosi con l’insegnamento della Chiesa, affondava le sue radici indietro nel tempo. Una storia – detto in breve – fatta di irriducibili incomprensioni, di contrasti politici, di tradimenti e di promesse infrante.
Quanto di questa secolare storia sia ancora presente nelle coscienze dei cattolici del nostro tempo è difficile dire, nonostante le continue sollecitazioni del Magistero della Chiesa (in ultimo la recente lettera pastorale di Papa Leone XIV, Disegnare nuove mappe di speranza) a proteggere e potenziare le scuole cattoliche, “non rifugio nostalgico, ma laboratorio di discernimento, innovazione pedagogica e testimonianza profetica”.
Sono ormai lontani gli anni 80, segnati dall’ultima appassionata stagione a sostegno della libertà scolastica, quando si verificò, in una parte del mondo cattolico italiano con il sostegno culturale di personalità laiche autenticamente liberali, una grande mobilitazione che impedì il tracollo di numerose scuole confessionali gravemente penalizzate dalla diminuzione di vocazioni o dalla decisione di alcuni istituti religiosi di rivolgere in altra direzione il loro impegno sociale.
In moltissimi casi le scuole furono “salvate” dalla coraggiosa intraprendenza di gruppi di laici che spesso attraverso la modalità cooperativa consentirono di proseguire esperienze talora secolari.
Mentre la loro esistenza appare oggi sempre più precaria per varie e ben note ragioni, non sembra che questo fenomeno costituisca tuttavia un motivo di particolare interesse se non per quanti (gestori, docenti, famiglie con i figli frequentanti) ne sono direttamente coinvolti. Nuove urgenze oscurano la questione della libertà di insegnamento (vista come espressione di un passato lontano) sul piano dell’impegno ecclesiale e della militanza dei cattolici come, per citarne alcune a titolo d’esempio, il tema della protezione dell’intero corso della vita, l’accoglienza immigratoria, l’impegno verso vecchie e nuove povertà, la carenza di vocazioni religiose.
E poi, perché battersi per rivendicare una libertà garantita nella scuola di tutti e cioè nella scuola dello Stato? Con l’autonomia delle scuole non è assicurato un sistema statale pluralistico nel quale varie idealità educative convivono e possono confrontarsi?
La questione della libertà non solo “nella scuola” ma “della scuola” ha da tempo oltrepassato gli storici confini confessionali e annovera da tempo (almeno dai dibattiti degli anni 80-90 che anticiparono la strada alla legge sulla parità del 2000) tra i suoi sostenitori una quota non marginale di intellettuali e personalità politiche che ritengono lo statalismo scolastico un residuo otto-novecentesco e un grave ostacolo per il rinnovamento delle pratiche e metodologie scolastiche. Non si intravvede tuttavia all’orizzonte una fecondazione politica in grado, se non di invertire drasticamente la rotta, almeno di garantire l’esistenza di esperienze libere coerenti con le aspettative delle famiglie.
Al di là delle rituali dichiarazioni, l’humus che alimenta l’attuale quadro politico (in egual misura le forze politiche di governo e di opposizione, con l’eccezione di chi inquadra il problema nell’ottica della sussidiarietà) è infatti centralistico-monopolistico, a trazione statalista o regionalista, comunque non schierata dalla parte del liberalismo scolastico.
A porre le premesse della situazione attuale, contrariamente a quanto solitamente si crede, non furono le componenti laiche ed anticlericali decise a impedire fin dagli anni del post-fascismo la creazione di un sistema scolastico pubblico misto, composto da scuole statali e scuole non statali, come indicato dalla Costituzione repubblicana. Beninteso, laici e anticlericali non persero occasione per combattere l’allora forte presenza scolastica cattolica, ma fu l’élite politica democristiana a capovolgere il popolarismo sturziano che aveva fatto della libertà scolastica uno dei suoi punti qualificanti, stabilendo un accordo nel 1923 con il ministro Gentile per l’introduzione dell’esame di Stato attraverso il quale si compì, di fatto, il tanto atteso riconoscimento delle scuole non statali.
Da allora in poi si sono succeduti tre snodi storici che hanno posto le premesse necessarie per la piena comprensione della situazione attuale.
1. Il primo riguarda l’aspro dibattito che si svolse nell’immediato dopoguerra negli ambienti cattolici su quale dovesse essere l’assetto scolastico post-fascista. Ispirandosi alla strategia delineata dal Codice di Camaldoli sul finire del conflitto, prevalse la tesi caldeggiata da Moro, Dossetti, La Pira, favorevoli alla scelta statal-continuista, convinti che solo lo Stato disponeva della forza per combattere l’ignoranza e assicurare un’istruzione secondaria all’altezza del rigore di quella gentiliana.
A nulla servirono le riserve di Pio XII, della Civiltà Cattolica, e l’opposizione di padre Gemelli – favorevoli invece al finanziamento di un sistema scolastico misto, statale e privato come suggeriva l’art 33 della Costituzione – e gli sforzi di De Gasperi e dell’allora ministro dell’Istruzione Gonella di trovare una soluzione di compromesso.
Gli “statalisti” democristiani erano convinti di assicurare una presenza cristiana nel mondo della scuola (e di “controllarne” l’elettorato) attraverso l’apparato ministeriale ereditato dall’ultimo fascismo, la presenza di molti insegnanti nelle aule parlamentari e l’attivismo delle associazioni professionali cattoliche dei maestri (Aimc) e dei professori (Uciim).
Ben presto questa scelta mostrò però tutti i suoi limiti. Uno studio condotto agli inizi degli anni 60 dal salesiano don Vincenzo Sinistrero documentava inequivocabilmente un primo netto arretramento del sistema delle scuole cattoliche non a causa della perdita di iscrizioni, ma perché il suo processo di crescita era molto più lento di quello degli istituti statali che si stavano moltiplicando su tutto il territorio nazionale.
2. Il secondo passaggio risale al 1963, quando prese forma il primo governo di centro-sinistra. I quattro partiti che ne facevano parte concordarono di rinviare la questione della parità scolastica e degli eventuali contributi dello Stato a un’apposita legge che per vedere la luce, e a quali condizioni diremo tra breve, dovette attendere 37 anni. La Democrazia cristiana abbandonava in sostanza le scuole non statali al loro destino, cedendo alle richieste dei socialisti, tra le cui fila militavano personalità politiche e pedagogiche (Tristano Codignola, Aldo Visalberghi, Raffaele Laporta) che negli anni precedenti erano state in prima fila nelle varie iniziative organizzate dagli ambienti laici per contrastare quella che era definita “la conquista confessionale” della scuola pubblica.
Con il centro-sinistra ci si allontanò ineluttabilmente dalle speranze suscitate da quanto era accaduto nella laicissima Francia con la legge Debré del 1959, che disegnò un sistema scolastico duale, statale/privato. Da questo momento in poi si restò in attesa della promessa legge che regolasse la materia, preceduta da un ampio dibattito e da accese polemiche su come intendere la natura della scuola dello Stato (Cassese), il rapporto Stato/privati (Valitutti, Gozzer), il superamento del principio dell’educazione nazionale (Del Noce) fino alla proposta più netta di una scuola pubblica non di Stato (Movimento popolare).
3. Con i governi della coalizione dell’Ulivo (1996-2001, ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer) si giunse infine, dopo circa mezzo secolo dalla Costituzione, a regolare la parità scolastica (legge 62/2000), ma limitatamente al riconoscimento giuridico “pubblico” delle scuole, rinviando la questione della copertura finanziaria a un non precisato successivo impegno restato finora, come è noto, in sospeso.
La parità berlingueriana era ancora concepita nell’ottica statalista, con il sistema statale preso a schema fondante per disegnare l’altra parte della scuola italiana: insomma si sarebbe potuto accedere alla parità nella misura in cui le scuole non statali avessero risposto a criteri mutuati in buona sostanza dal sistema statale.
Si finì così per perdere non solo l’occasione di un equo riparto economico, ma si rinunciò a incoraggiare le scuole paritarie a diventare agenti di innovazione e sperimentazione di nuovi e inediti modelli di apprendimento e di socialità, dimostrando con i fatti che un’“altra scuola” è possibile.
Se non si entra in un nuovo paradigma culturale, politico e pedagogico (da un lato la lettura della parità alla luce della sussidiarietà e l’intervento delle Regioni in favore delle famiglie, dall’altro le migliori risorse intellettuali delle scuole non statali messe a disposizione della ricerca e dell’innovazione educativa), mi sembra difficile che i riconoscimenti attesi dagli istituti paritari siano il volano per sciogliere le incrostazioni consolidate da molti decenni.