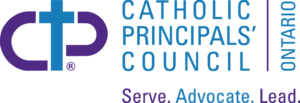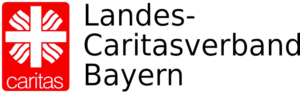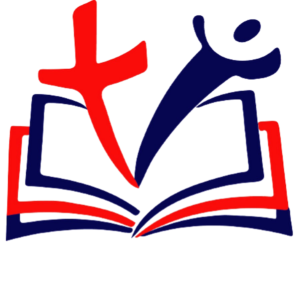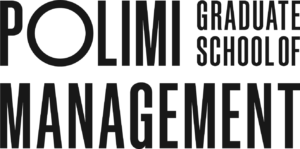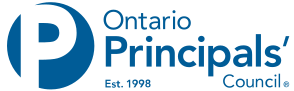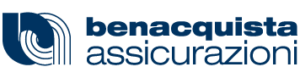Articolo di Giuliano Fasani

L’articolo di Tiziana Pedrizzi sull’utilizzo dei dati Invalsi e gli studi di caso relativi, mi hanno suggerito alcune riflessioni che vorrei condividere con voi.
Mi riferisco in particolare ai seguenti passaggi.
“Infine per quanto riguarda didattica e curricoli: collegialità interdisciplinare basata sulle competenze di base, centratura sullo studente, modelli comuni di progettazione, valorizzazione delle dimensioni pratiche e professionali delle competenze di base. Insomma tutti i must be degli ultimi decenni (una volta si diceva dover essere), fra cui è difficile, anche se ineludibile, scegliere le priorità.
Ma sono state considerate anche politiche di carattere strutturale, la cui responsabilità esorbita dalle possibilità e competenze delle scuole.
Orientamento più efficace alla scuola media: presumibilmente si intende la presa in considerazione della formazione per il lavoro che invece è considerata dai docenti generalmente come il refugium peccatorum.
Nocciolo duro delle competenze di base trasversali nel biennio iniziale comune: e qui c’è forse da domandarsi se non si sia già fatto abbastanza, soprattutto per gli istituti professionali, il luogo dei maggiori abbandoni, ormai chiaramente causati dal peso quantitativo e qualitativo della formazione generalista.”
Ritengo che anche l’Esame di Stato possa fornire dei dati interessanti che, se fossero raccolti e analizzati, potrebbero aiutare a fare passi avanti per approfondire alcune questioni nodali. Naturalmente qui prescindo dalle questioni legate all’esame e mi rendo conto che alcune considerazioni sono condizionati dalle modalità di svolgimento dell’esame stesso.
Ho scelto di fare il presidente di commissione d’esame di stato anche se sono in pensione perché è bello incontrare i giovani in un momento importante della loro vita e perché in questa occasione si possono constatare con mano gli esiti di cinque anni di studi, a volte faticosi e problematici.
Per due anni sono stato al Liceo Linguistico, l’anno scorso all’Istituto Tecnico, quest’anno all’Istituto Professionale con i seguenti indirizzi: “Servizi Commerciali” (ex segretarie d’azienda) e “Servizi Culturali e dello Spettacolo”.
Confesso subito la mia ipotesi di fondo: c’è bisogno di riconsiderare le materie di studio per puntare su un curricolo opzionale che valorizzi le discipline dell’indirizzo scelto e i punti di forza degli studenti.
Qui faccio riferimento all’esperienza e ai dati di quest’ultimo anno.
Erano due classi, la prima di 20 alunni, la seconda di 30. Tutti gli alunni hanno conseguito il diploma. In quest’ultima (SCS) 15 alunni provenivano da un Istituto Cattolico di Formazione nel quale gli alunni avevano svolto il quinto anno per poter accedere all’Esame di Stato. Nei quattro anni precedenti si erano specializzati in grafica, l’ultimo anno hanno affrontato altre discipline d’indirizzo. I commissari delle materie d’indirizzo hanno faticato parecchio a cercare e a trovare le loro competenze in questi campi. Osservo poi che i docenti interni non conoscevano questi alunni, se si esclude lo scrutinio finale prima dell’Esame di Stato.
Provo alla luce dell’ipotesi proposta a prendere in considerazione alcune materie che si trovano in tutti gli indirizzi di studi secondari superiori.
ITALIANO
Prova scritta. La traccia “letteraria” è stata scelta da 4 alunni su 50 e gli esiti non sono stati molto positivi. Un’alunna non madre lingua italiana ha scritto un testo che potrebbe essere di livello A1. Molti alunni hanno faticato a mettere insieme i pensieri e le argomentazioni. Le insufficienze sono state 8 nella prima classe, altrettante circa nella seconda. Pochi altri alunni sono stati molto bravi.
Orale.
Quasi indipendentemente dal documento proposto, gli alunni nelle due classi hanno parlato con frequenza Gabriele D’Annunzio, quasi sempre gli studenti riferivano della sua vita e dei suoi amori, la letteratura era veramente marginale. Qualche volta gli studenti hanno parlato di Verga e Ungaretti. Un alunno ha citato Montale con grande meraviglia della docente di italiano. Parlando di questi autori gli alunni hanno fatto riferimento ad alcune poesie, per quel che ricordo io, le medesime che si studiano alle medie. In genere gli studenti raccontavano la vita degli autori e nei casi migliori qualche ricordavano qualche concetto chiave. Anche qui la letteratura era secondaria.
Negli Istituti professionali la lingua e la letteratura italiano si studiano per quattro ore settimanali nel biennio e nel triennio.
STORIA
Prova scritta.
Un alunno su 50 ha scelto il saggio storico. Si è dimostrato poi uno dei più bravi.
Prova orale.
La grande maggioranza degli alunni ha parlato della prima guerra mondiale. Anche qui con riferimenti casuali al documento proposto. La quasi totalità degli alunni si è limitata a riferire l’inizio della guerra, con l’immancabile riferimento a Sarajevo. Gli argomenti ricorrenti erano l’ascesa di Mussolini, di Hitler e la seconda Guerra Mondiale. Qualcuno ha parlato della Belle Époque e della crisi del 1929. Diversi alunni facevano fatica a collocare temporalmente gli avvenimenti storici. I contenuti riferiti erano piuttosto scarsi. Quando si parlava di Mussolini ci si riferiva solo all’ascesa al potere, così come per Hitler. Anche per la seconda guerra mondiale si parlava solo delle fasi iniziali.
Naturalmente andavano fortissimo gli abbinamenti Prima Guerra Mondiale & Ungaretti, Prima Guerra Mondiale & D’Annunzio, Mussolini & D’Annunzio.
Nel biennio si studiano 2 ore di storia&geografia e nel triennio si fanno 2 ore di storia.
INGLESE
Come si sa in questi indirizzi c’è solo l’orale.
La maggior parte degli alunni sapeva parlare in inglese solo di un argomento scelto da loro non senza molti errori e con una pessima pronuncia. In alcuni casi la docente ha dovuto a ricorrere a “What’s your name?”. L’unica alunna con una buona “fluency” ha imparato l’inglese per conto proprio. Un alunno si è rifiutato di parlare in inglese.
Nell’indirizzo “Servizi commerciali” si studiano due lingue straniere. Inglese si studia per tre ore settimanali nel biennio e due ore nel triennio.
Nell’indirizzo “Servizi Culturali e dello Spettacolo” inglese si studia tre ore settimanali nel biennio e nel triennio.
Il livello di inglese atteso alla fine dell’Istituto Professionale è B1 o anche B2, temo che il livello medio degli studenti si attesti invece su A1 – A2, che è il livello atteso alle medie.
ORIENTAMENTO
Questo secondo me dovrebbe essere il punto sul quale riflettere di più sulla base dei dati che si possono raccogliere.
Vado a memoria e quindi i dati non sono accurati e la somma non fa 100.
Il 20 – 30 % farà un lavoro che non richiede il diploma.
Ricordo due ragazzi che già lavorano, uno fa il pizzaiolo, l’altro il piastrellista.
Il 10 – 20% farà un lavoro che richiede il diploma ma non quello conseguito.
Il 20 – 30 % farà l’università, di questi un buon 10 – 15 % non farà seguirà un indirizzo di studi coerente con la scuola superiore. Una percentuale minima frequenterà gli ITS.
Il 20 – 30% si inserirà nel mondo del lavoro coerentemente con gli studi fatti.
Concludendo.
L’Esame di Stato mi sembra sempre più problematico e nutro forti dubbi sulla sua utilità.
Accanto ai dati Invalsi che rilevano un aspetto oggettivo della valutazione credo sia molto importante una raccolta dei dati riguardo all’orientamento post-diploma e alle conoscenze e competenze che si possono verificare durante lo svolgimento dell’Esame di Stato. Certo questi ultimi a mio parere sono più “soggettivi”, riflettono in sostanza la valutazione dei docenti, ma l’analisi e il confronto dei due tipi di dati potrebbe essere interessante.
Mi pare che questa esperienza confermi l’ipotesi che ho proposto all’inizio.