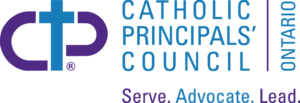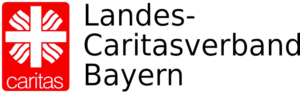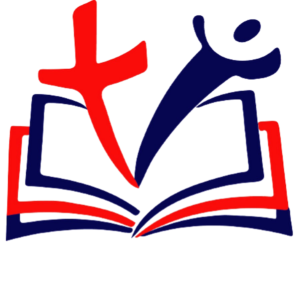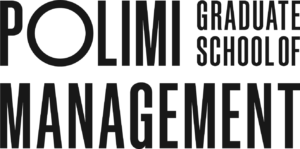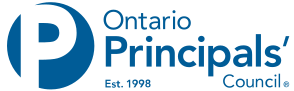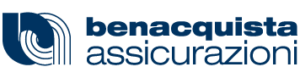Fonte: Sussidiario.net
Articolo di Nora Terzoli

Personalizzare significa adattare contenuti e metodi al profilo specifico dello studente. All’opposto, la standardizzazione rende la scuola inutile
Tante sono le tematiche e le prospettive con cui si possono leggere le dinamiche della scuola. Alcune dettate da fatti di cronaca emergenti, che vedono protagonisti gli studenti o il personale della scuola, altri dalla pubblicazione di report, ricerche che fanno il punto di volta in volta su qualche aspetto delle istituzioni scolastiche.
La complessità, che a volte può anche essere letta come vivacità della scuola, consente diverse chiavi di lettura. Senza la pretesa di identificare quella più adeguata, si propone di seguito la centralità della “personalizzazione” come prospettiva per riflettere su alcune azioni del fare scuola.
Si tratta innanzitutto di procedere con una precisazione, senza la quale questa parola, forse ancora oggi, rischia di vedere ridotta la sua portata semantica, quando la si considera come fosse un sinonimo di semplificazione, espressione di un’educazione “individualista”.
La personalizzazione ha a che fare invece con la costruzione di un contesto dove ciascuno possa apprendere secondo le proprie potenzialità, contribuendo alla costruzione di un “sapere sociale” all’interno del quale il punto di vista di ciascuno diventa occasione per l’approfondimento di una ricerca che potenzialmente non ha mai fine.
Personalizzare non significa semplificare la progettazione didattica per gli studenti in difficoltà, ma progettare percorsi didattici capaci di intercettare interessi, stili cognitivi, tempi di apprendimento e motivazioni differenti, mettendo al centro la persona nella sua interezza.
Questo approccio aiuta a comprendere che occorre superare, nel caso in cui permanesse ancora, l’idea di una scuola “uguale per tutti”, fondata su curricoli standardizzati e metodologie uniformi e aprire a una scuola che si modella sui diversi bisogni degli studenti, che accoglie tutte le espressioni dell’umano.
La personalizzazione non si configura dunque come una deroga, ma come un principio strutturale dell’azione educativa. Si tratta di costruire ambienti di apprendimento flessibili, in cui ciascuno possa trovare spazio per esprimersi e per contribuire attivamente alla vita scolastica, si tratta di mettere lo studente al centro del processo di insegnamento-apprendimento, anche grazie alla ridefinizione dei curricoli.
La personalizzazione chiede infatti curricoli aperti, che consentano scelte, percorsi e attività diversificate e la partecipazione attiva degli studenti nella costruzione dei percorsi formativi.
Si tratta di favorire una co-progettazione del curricolo: non un percorso calato dall’alto, ma il risultato di un dialogo tra insegnanti, studenti e, in alcuni casi, famiglie e comunità territoriali.
Una scuola così strutturata è in grado di motivare, coinvolgere maggiormente gli alunni e riconoscere il valore delle competenze trasversali, di quelle Non Cognitive Skills ritenute ormai fondamentali per il mondo contemporaneo: autonomia, pensiero critico, collaborazione, capacità di scelta.
È necessario costruire curricoli non gonfi di contenuti, estesi, quanto capaci di profondità, di mettere in azione l’intelligenza degli studenti, di promuovere la ricerca di senso.
Per la loro costruzione sono imprescindibili selettività e riflessività, così le nozioni non diventano espressioni di arida erudizione, ma strada per conoscere la realtà nelle sue diverse manifestazioni.
Percorsi in cui l’intelligenza si accende, si potrebbe dire “risuona”, come ricorda una recensione a un’importante opera di Hartmut Rosa Pedagogia della risonanza: “La classe della Pedagogia della risonanza è un campo costruito su due assi di risonanza, quello diagonale delle materie, interpretate come ‘sfere di azione e di vita’ e ‘ritagli di mondo’, e quello orizzontale delle relazioni. Quanto al primo, se queste materie-mondi toccano le corde dell’allievo, aprono un asse di risonanza, o, quando al contrario prevale l’alienazione, restano per lui indifferenti, se non finisce addirittura per odiarle”.
E ancora: “Anche l’asse orizzontale, quello sociale dell’atmosfera che si respira in una classe e in generale a scuola, è decisivo per aprirsi a esperienze di risonanza, tanto per gli studenti quanto per l’insegnante. La riuscita di una lezione dipende dall’attivazione di entrambi: un rapporto in cui risuona un solo asse, mentre l’altro è muto, sul lungo periodo è instabile”.
“Un processo formativo può quindi dirsi riuscito se favorisce l’apertura di assi di risonanza verticali e orizzontali e il formarsi di una disposizione stabile e di una spiccata sensibilità per questo tipo di esperienza. Quindi non più o discipline o relazioni, ma relazioni attraverso le discipline”.
Relazioni attraverso le discipline: un’espressione sintetica per indicare la dinamica di un apprendimento che ha il suo cuore nella scoperta della realtà attraverso le discipline che sono punti di vista con cui investigare il reale.
Ricerca che si snoda attraverso la relazione con i docenti, che, come i maestri delle botteghe medievali, introducono gli studenti nel loro lavoro artigianale di indagine del reale con l’aiuto di tutti gli strumenti professionali di cui dispongono e relazione con gli altri studenti, perché la scoperta e il sapere sono un’opera sociale, non individualistica.
I curricoli animati dal principio della personalizzazione non possono essere ridotti a tabelle di competenze corredate da conoscenze e abilità, con relative richieste di performance, ma percorsi per raggiungere una dimensione di senso capace di mettere in azione l’io dello studente.
Curricoli non standardizzati, ma “risonanti”, finalizzati a generare quell’incontro tra asse orizzontale e verticale della risonanza, citando Hartmut Rosa.
La centralità della persona, la “personalizzazione” non ha dunque come sua principale caratteristica identificativa la semplificazione, la sottrazione, quanto l’indicazione di una direzione: la fioritura dell’umano attraverso la relazione e la passione per la conoscenza della realtà e la generazione di una cultura viva.
Curricoli pensati non per uniformare, per standardizzare i processi della conoscenza, ma per mettere in azione la libertà degli studenti, percorsi dai quali emergano con chiarezza i nuclei essenziali del sapere con una esplicita connotazione interdisciplinare, espressione di itinerari in cui si intrecciano l’acquisizione di contenuti, abilità e strumenti e la realizzazione di lavori e di opere di cui gli studenti siano protagonisti.
Personalizzazione e innovazione costituiscono un binomio inscindibile del fare scuola. Tecnologie digitali, didattica laboratoriale, valutazione formativa, tutoraggio tra pari, uso intelligente dei dati per monitorare i progressi, sono alleati preziosi per costruire percorsi personalizzati e significativi.
La personalizzazione favorisce un approccio più dinamico, esplorativo e interattivo e rappresenta non solo una risposta alle esigenze degli studenti, ma anche una sfida professionale per i docenti, chiamati a rinnovare le proprie pratiche e a lavorare in team in modo sempre più collaborativo e riflessivo.
Riconoscere la personalizzazione come principio fondante significa cambiare paradigma: non più una scuola centrata su rigidi curricoli, ma sulle persone, non una scuola che seleziona, ma una scuola che potenzia, non una scuola che standardizza, ma una scuola che diversifica.
In quest’ottica la personalizzazione non è un lusso né una concessione: è una necessità per tutti gli studenti e una responsabilità dell’intera comunità scolastica. È la strada maestra per costruire una scuola realmente inclusiva, equa e capace di formare cittadini competenti, consapevoli e pronti a contribuire a una società in continua trasformazione.
Per comprendere la centralità e la dinamica della personalizzazione a scuola può essere utile un paragone con la personalizzazione della cura in campo medico, dove non si tratta solo di adattare le terapie al quadro clinico, ma di considerare l’individuo nella sua interezza: genetica, stile di vita, valori, preferenze e contesto sociale.
In questa prospettiva il medico non è il solo detentore del sapere, ma un interlocutore che co-costruisce il percorso di cura insieme al paziente. Una visione che si fonda sulla relazione, sull’ascolto attivo e su un approccio multidisciplinare. La medicina personalizzata promette cure più efficaci e mirate, ma allo stesso tempo richiama l’etica della cura: riconoscere la singolarità di ogni persona malata, non solo come “caso clinico”.
Per analogia la personalizzazione a scuola non può trascurare l’ascolto dello studente, fino ad arrivare al riconoscimento e alla valorizzazione dei suoi talenti, la relazione come strumento di cura e di apprendimento, la valorizzazione della diversità; la personalizzazione non è un’eccezione per chi è “fuori norma”, ma un principio generale che riconosce l’originalità di ciascuno.
Educare e curare condividono lo stesso obiettivo: aiutare l’essere umano a realizzare il proprio potenziale, che sia quello di apprendere o di guarire, ma sempre e comunque quello di far fiorire l’umano nella totalità dei suoi fattori e delle sue manifestazioni.