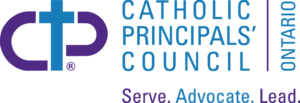Fonte: Sussisidiario.net
Articolo di Giorgio Chiosso

Dieci anni fa viveva il suo momento ruggente la “Buona scuola” renziana. Far girare bene la macchina, questo era l’obiettivo. Lasciò una mega-sanatoria
La “Buona scuola” del governo Renzi (2014-2016, ministro dell’Istruzione Stefania Giannini), aspramente contestata al momento della sua entrata in vigore, non ha raccolto simpatie o nostalgie neppure in seguito, quando la bufera politica si attenuò. A riguardare l’agenda politico-scolastica a dieci anni di distanza è come restasse una pagina bianca.
Siamo ben lontani dallo storico peso che accompagnò la rivoluzione scolastica britannica con i provvedimenti noti come “riforma Blair” (2006) a cui Renzi neppure troppo velatamente si ispirò, sperando di allineare anche l’Italia nella modernizzazione scolastica in corso in Europa dietro la regia dell’OCSE. Gli unici a conservare una buona memoria della legge 107/2015 sono le molte migliaia di precari che furono ope legis stabilizzati nei ruoli dello Stato.
Con il progetto Renzi-Giannini si compiva una svolta significativa rispetto alla tendenza prevalente della politica scolastica fine e post novecentesca. Tre le caratteristiche.
La prima – e più evidente nel breve periodo – era il rilancio di finanziamenti alla scuola dopo i bruschi tagli degli anni precedenti (Tremonti-Gelmini), fino a immaginare nell’ottica del risparmio il ritorno del maestro unico nelle scuole primarie.
La seconda era la netta priorità assegnata agli aspetti organizzativi e gestionali rispetto all’impianto ordinamentale, in linea con una scelta politica che poneva l’efficienza al posto d’onore.
La terza, infine, era una sostanziale estraneità verso le finalità e l’impianto culturale dell’insegnamento (salvo qualche marginale aspetto relativo alle discipline artistiche), finalità e risorse valoriali che restavano sullo sfondo e che, nelle intenzioni del ministro dell’Istruzione e del presidente del Consiglio, avrebbero dovuto attenuare i contrasti ideologici.
La scuola era insomma concepita soprattutto come un’organizzazione efficiente da poter misurare e valutare alla luce dei risultati conseguiti in piena linea di contiguità con le teorie school effectiveness. Non che docenti, studenti, famiglie non comparissero nei documenti ufficiali e nella consultazione che precedettero la stesura della legge, ma erano disposti sullo sfondo della scena, più spettatori che protagonisti. L’interesse dominante era come far girare bene la macchina scolastica.
Non a caso la regia della riforma renziana era affidata a un gruppo di tecnocrati bene introdotti nella cultura manageriale e delle organizzazioni, ma con scarsa familiarità con la vita scolastica quotidiana, i suoi ritmi e le sue tacite consuetudini. Gli uomini di scuola che a vario titolo (pedagogisti, psicologi, filosofi) avevano pilotato i cambiamenti precedenti erano solo marginalmente o formalmente coinvolti nei “cantieri” che predisposero il progetto della “Buona scuola”.
Il tentativo di cambiare con una spallata la vecchia scuola in nome della modernizzazione – la legge, invero, al di là dell’ispirazione generale aveva qualche aspetto apprezzabile come, per esempio, l’ampliamento dell’autonomia delle scuole e una maggiore sensibilità per i cambiamenti legati allo sviluppo del digitale – sortì magri risultati e a poco a poco scomparve dalle prime pagine della scena scolastica, rigettata non solo dai sindacati, ma dalla stragrande maggioranza degli insegnanti e, infine, smantellata pezzo a pezzo dai ministri post-renziani.
Sul rafforzamento del ruolo del capo di istituto, sui riconoscimenti premianti previsti per gli insegnanti migliori e più laboriosi, sulle nuove modalità di formazione dei docenti e di assegnazione del posto di insegnamento cadde una vera e propria pietra tombale. Le norme sull’alternanza scuola-lavoro furono rapidamente riviste e le sole disposizioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale superarono le diffuse diffidenze che accompagnarono l’intera stagione della “Buona scuola”.
Lo sfortunato tentativo di Renzi-Giannini merita qualche puntualizzazione storica al di là dei risultati politico-scolastici mancati.
La prima suggerisce che la riforma Renzi-Giannini costituisce il tornante che cerca di spostare la ragion d’essere della scuola dalla trasmissione culturale al tecno-efficientismo scolastico. Con la “Buona scuola” si supera il modello delle riforme novecentesche distese a largo raggio e centrate organicamente su un concetto forte di cultura e di educazione, cui appartengono ancora a pieno titolo i progetti dei ministri Berlinguer e Moratti.
Ma neppure il passaggio da una visione generale agli interventi di settore sfugge alla doppia opposizione, da un lato quella rumorosamente pilotata dal sindacato, e dall’altro quella sostenuta dal silente conservatorismo del mondo degli insegnanti, che – spesso lo si dimentica – costituisce il basso continuo della storia scolastica italiana. È sempre più chiaro che se non si dispone dei pieni poteri gentiliani (e neppure il ministro-filosofo ebbe vita facile) o di un larghissimo consenso è impossibile dar vita a una riforma con la erre più o meno maiuscola.
Nonostante ogni sforzo per coinvolgere i docenti il progetto Renzi-Giannini fu approvato nel dissenso generale e con voto di fiducia in Parlamento, alimentando l’idea di un provvedimento calato dall’alto. Fatale fu l’illusione che il consenso di qualche élites professionale e il parere elogiativo di qualche compiacente intellettuale ingaggiato per l’occasione avesse il potere di modificare il corso della vita scolastica.
Se manca un nucleo di princìpi ideali trainanti in grado di riscaldare la professionalità dei docenti e di sollecitarne l’impegno educativo, se manca la centralità dell’allievo nell’apprendimento e nella relazione interpersonale, qualsiasi cambiamento è destinato a mala sorte. Non basta disporre di un’auto confortevole e di un serbatoio pieno di carburante per compiere un bel viaggio.