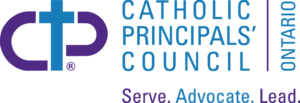Una compagnia professionale al lavoro
Ispirata dall’amicizia, dal dialogo e dalla solidarietà
Una compagnia professionale al lavoro
Ispirata dall’amicizia, dal dialogo e dalla solidarietà
La prima associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie, autonome e libere
Disal è un’opportunità di solidarietà nella professione tra dirigenti di scuole statali e coordinatori didattici di scuole paritarie, che attraverso un’amicizia professionale intende offrire contributi concreti nel lavoro quotidiano di direzione delle scuole. Promuove momenti di lavoro comune a livello regionale e nazionale, senza tralasciare il confronto con esperienze all’estero, finalizzati alla valorizzazione di una direzione che, nella cura di ogni aspetto tecnico e organizzativo, abbia al centro la sfida educativa e culturale, che investe la nostra società.
La prima associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie, autonome e libere
Disal è un’opportunità di solidarietà nella professione tra dirigenti di scuole statali e coordinatori didattici di scuole paritarie, che attraverso un’amicizia professionale intende offrire contributi concreti nel lavoro quotidiano di direzione delle scuole. Promuove momenti di lavoro comune a livello regionale e nazionale, senza tralasciare il confronto con esperienze all’estero, finalizzati alla valorizzazione di una direzione che, nella cura di ogni aspetto tecnico e organizzativo, abbia al centro la sfida educativa e culturale, che investe la nostra società.
OLTRE 20 ANNI DI STORIA
Dalla sua formale fondazione nel 2001 DiSAL lavora per la formazione e la ricerca di una visione di scuola e di dirigenza scolastica capace di valorizzare l’autonomia e la sinergia tra istituzioni scolastiche e territorio e di sviluppare percorsi innovativi di miglioramento professionale. Per farlo, collabora con altre associazioni nazionali e internazionali che si occupano di scuola e, in particolare, di direzione scolastica, è in dialogo con il Ministero e con il mondo delle università e dell’alta formazione. Leggi a lato i nostri valori e naviga nel sito per conoscere i nostri giudizi e le nostre proposte.
VALORI
OLTRE 20 ANNI DI STORIA
Dalla sua formale fondazione nel 2001 DiSAL lavora per la formazione e la ricerca di una visione di scuola e di dirigenza scolastica capace di valorizzare l’autonomia e la sinergia tra istituzioni scolastiche e territorio e di sviluppare percorsi innovativi di miglioramento professionale. Per farlo, collabora con altre associazioni nazionali e internazionali che si occupano di scuola e, in particolare, di direzione scolastica, è in dialogo con il Ministero e con il mondo delle università e dell’alta formazione. Leggi a lato i nostri valori e naviga nel sito per conoscere i nostri giudizi e le nostre proposte.
VALORI
Ultimi articoli
02/04/2025
Vita dell'associazione
Il convegno nazionale DiSAL ad Arezzo ripropone il tema della direzione pedagogica: a scuola i dirigenti devono guidare sistemi per educare la persona L’emergenza educativa e la complessità chiedono, oggi, una prospettiva pedagogica attorno alla [...]
02/04/2025
Esperienze dalla scuola
Dal 3 al 5 aprile ad Arezzo si terrà il convegno nazionale di Disal “Guidare sistemi per la persona”. Nella scuola il dirigente ha un ruolo irriducibile Nella percezione diffusa di molti le istituzioni assumono [...]
31/03/2025
Associazione,Vita dell'associazione
Un fatto nuovo tra le due sponde dell’Adriatico. La formazione con la rete delle scuole cattoliche albanesi Nelle giornate del 28 febbraio e del 1 marzo 2025 si è svolto, sulla costa di Durazzo, il [...]
31/03/2025
Approfondimenti
La Direzione Nazionale DiSAL propone una riflessione sul Documento Nuove Indicazioni Nazionali. Materiali per il dibattito pubblico Visioni Chiavi di lettura La vera novità che le Indicazioni possono portare al Sistema scolastico italiano si identifica: [...]
24/03/2025
Associazione,Vita dell'associazione
Nel pomeriggio del 19 marzo 2025 presso l’Istituto Europeo Leopardi a Milano si è tenuto il laboratorio di formazione Disal sul tema “La valutazione alla scuola primaria: tra norma e autonomia” Il prof. Pasolini, dirigente [...]
Ultimi articoli
02/04/2025
Vita dell'associazione
Il convegno nazionale DiSAL ad Arezzo ripropone il tema della direzione pedagogica: a scuola i dirigenti devono guidare sistemi per educare la persona L’emergenza educativa e la complessità chiedono, oggi, una prospettiva pedagogica attorno alla [...]
02/04/2025
Esperienze dalla scuola
Dal 3 al 5 aprile ad Arezzo si terrà il convegno nazionale di Disal “Guidare sistemi per la persona”. Nella scuola il dirigente ha un ruolo irriducibile Nella percezione diffusa di molti le istituzioni assumono [...]
31/03/2025
Associazione,Vita dell'associazione
Un fatto nuovo tra le due sponde dell’Adriatico. La formazione con la rete delle scuole cattoliche albanesi Nelle giornate del 28 febbraio e del 1 marzo 2025 si è svolto, sulla costa di Durazzo, il [...]
31/03/2025
Approfondimenti
La Direzione Nazionale DiSAL propone una riflessione sul Documento Nuove Indicazioni Nazionali. Materiali per il dibattito pubblico Visioni Chiavi di lettura La vera novità che le Indicazioni possono portare al Sistema scolastico italiano si identifica: [...]
24/03/2025
Associazione,Vita dell'associazione
Nel pomeriggio del 19 marzo 2025 presso l’Istituto Europeo Leopardi a Milano si è tenuto il laboratorio di formazione Disal sul tema “La valutazione alla scuola primaria: tra norma e autonomia” Il prof. Pasolini, dirigente [...]